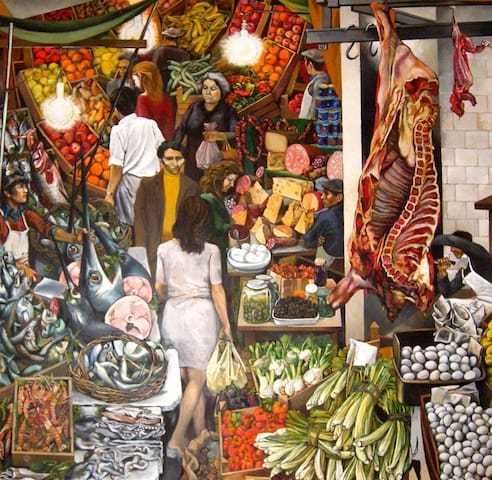Visite ai monumenti più vicini
Dalla metà del XIX secolo, nella chiesa di San Domenico è accolto il Pantheon degli Illustri di Sicilia, uomini e donne distinti per meriti più variegati: letterati, giuristi, artisti, poeti, personalità di importanza civile e politica.
In chiesa si possono ammirare lapidi, tombe, cenotafi e targhe che ne commemorano il ricordo.
Nel 2015 la comunità dei frati Predicatori del convento di San Domenico di Palermo si è fatta promotrice della realizzazione di un monumento funebre per il magistrato Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia insieme alla moglie e alla sua scorta il 23 maggio 1992. Dal 23 marzo 2024 riposa a San Domenico anche il grande scrittore siciliano di fama mondiale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore di uno dei romanzi più fortunati della narrativa italiana del secolo XX "Il Gattopardo", tradotto in tutte le lingue del mondo.
Il Pantheon continua ad essere un luogo vivo della memoria e dell’identità dei siciliani; un luogo in cui ad essere commemorati siano uomini che con il loro impegno – e nel caso di Giovanni Falcone sino al sacrificio della propria vita – hanno contribuito al riscatto della nostra terra.
La monumentale chiesa di San Domenico, costruita in questa forma a partire dal 1640, è anche il Pantheon degli uomini illustri di Sicilia: nelle tre navate della sua imponente architettura barocca trovano riposo il grande storico del Vespro siciliano e degli Arabi in Sicilia, Michele Amari (1806-1889); il poeta Giovanni Meli (1740-1815), vero e proprio corifeo della poesia dialettale del '700 palermitano; l'appassionato cultore di storia palermitana universalmente noto come il marchese di Villabianca (1720-1802); il più grande studioso delle tradizioni popolari siciliane, Giuseppe Pitré (1841-1916); il chimico Stanislao Cannizzaro (1826-1910) e, dopo innumerevoli altri che hanno dato dignità e onore a tutta la Sicilia, nel 2015 sono state traslate a San Domenico le spoglie del giudice palermitano Giovanni Falcone, ucciso barbaramente dalla mafia nel 1992. Nel 2019 ha qui trovato riposo l'archeologo marino Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso in un incidente aereo.
I Domenicani, giunti a Palermo già nel 1216, furono dapprima ospitati nel monastero di S. Matteo al Cassaro, nell'area dell’odierno monastero di S. Caterina, rimasto vuoto dopo il trasferimento delle monache basiliane al monastero del Ss. Salvatore.
A partire dal 1300 fu decisa l'edificazione del nuovo e più grande complesso conventuale, per il quale fu scelta quest'area risultante dal progressivo interramento del porto. Appartengono alla primitiva costruzione le tre corsie superstiti del chiostro, sulla sinistra della chiesa attuale.
La chiesa di S. Domenico venne quasi totalmente rifatta nel 1458 (di questa seconda edificazione non rimangono che alcuni tratti murari della tribuna), ed infine nel 1640, quando i padri Domenicani vollero ingrandirla. Il nuovo edificio risultò tanto ampio da sacrificare la corsia meridionale del chiostro ed occupare parte della piazza antistante. Per la costruzione delle prime due cappelle di destra fu pure demolita la cappella di S. Orsola che insisteva sull'attuale via Meli.
Il luogo in cui sorgeva il complesso conventuale, infatti, era divenuto, in tre secoli, un fitto intrigo di vicoli molto animati per via della vicinanza col porto e con le attrezzature mercantili della zona. La strada su cui la chiesa prospettava (identificabile col proseguimento della via Gagini) formava uno slargo proprio in corrispondenza della chiesa. Nel 1724, quando venne data sistemazione alla piazza, anche la facciata della chiesa ebbe una nuova veste. Questa, infatti, nel progetto originario seicentesco non prevedeva il grandioso telaio di colonne straccato dal paramento che invece fu realizzato. È probabile che la scelta sia stata influenzata da altri esempi palermitani, come la vicina chiesa di S. Ignazio o quella della Pietà, tuttavia, in questo caso risultò maggiore lo sviluppo orizzontale. I lavori della facciata si protrassero per circa 50 anni sotto la direzione di diversi architetti, tra cui Tomaso Maria Napoli, Andrea Palma, che si dedicò ai lavori del campanile destro, Giovanni Biagio Amico, Cosimo Agnetta e Lorenzo Olivier. Coppie di colonne, aggettanti rispetto al filo murario, dividono il prospetto in tre partiti; le colonne proseguono nel secondo ordine solo nel
partito centrale, mentre i laterali sono animati da nicchie e dalle statue dei papi domenicani. La pagina muraria risulta mossa dalle cromie degli stucchi, realizzati nel 1756 da Giovanni Maria Serpotta, e dalle statue che si stagliano contro il fondo trattato ad intonaco. L'insieme prende slancio verticale coi due campanili laterali, uniti al frontone curvilineo da due aeree balaustre.
La stesura complessiva della chiesa è seicentesca. Il progetto viene attribuito secondo alcuni ad Andrea Cirrincione, secondo altri a Vincenzo Tedesco. La pianta è a croce latina con ampie navate ed esteso transetto; la profonda tribuna termina con un catino semicircolare. L'interno, privo di ornamenti, fu completato intorno al 1690 e deve la sua eccezionale eleganza alle classiche e solenni forme architettoniche, e si arricchisce delle opere d'arte contenute nelle cappelle. Alcune di queste sono state riccamente ornate da altari in marmo, pitture e stucchi nel XVIII secolo.
Dal XIX secolo vi hanno trovato sepoltura gli uomini più illustri della città e la chiesa è considerata il “pantheon" di Palermo. Le sepolture ed i monumenti sono segnalati da apposite targhe, pertanto, vengono qui indicati solo i principali. Lateralmente all'ingresso sono due acquasantiere con rilievi del XV secolo. La prima cappella della navata destra è intitolata alla Madonna di Lourdes; vi è posto il monumento funebre di Emanuele Emanuele Gaetani, marchese di Villabianca, erudito e storico delle vicende cittadine, eseguito da Leonardo Pennino nel 1802 con rilievo della Trinacria. La terza cappella, Interamente ricoperta in marmi mischi, è la sepoltura della famiglia Oneto di Sperlinga; sull’altare, con colonne tortili, è la statua di s. Giuseppe di Antonello Gagini; alle pareti sono stucchi e puttini in rilievo. Ai lati sono due monumenti funebri in marmi mischi, perfettamente armonizzati alle decorazioni parietali: a destra quello di Marianna Oneto Monroy, a sinistra quello di Giacomo Majorca, conte di Francavilla. Segue la cappella dedicata a S. Anna con tela di Rosalia Novelli (XVII sec.), tra due belle statue muliebri; l'altare ha cornici in marmi mischi; ai lati due sarcofagi del XVII secolo, in marmi mischi come la balaustra. Nella quinta cappella è il monumento funebre ad Emerico Amari, eseguito da Domenico Costantino nel 1875; il patriota e giurista palermitano è raffigurato su una seggiola posta su un'alta ara, in cui è un rilievo marmoreo. Lateralmente sono i monumenti a Gaetano Daita, letterato e poeta, di Vincenzo La Parola (1903), ed a Salvatore Vico Patania, di Benedetto Civiletti (1877). La successiva cappella, preceduta da una bella balaustra curvilinea, ha altare in marmi policromi e timpano mistilineo spezzato con marmo e piatte paraste in marmo rosso e giallo; ai lati sono due sarcofagi; alle pare
ti è realizzata a fresco un'architettura fittizia.
Il transetto ha analoghi altari realizzati nel 1758 secondo un solenne ed articolato disegno di padre Lorenzo Olivier: coppie di colonne sfalzate sorreggono timpani mistilinei spezzati che culminano centro in stemmi sorretti da angeli; le decorazioni sono in marmi vari, i capitelli estremamente lavorati e le cornici doppie. Gli altari hanno volute laterali e fregi in bronzo e sono preceduti da balaustre in marmi mischi. L'altare di destra è dedicato a S. Domenico, con tela di Filippo Paladini; sulle pareti laterali sono vari altari e monumenti tra questi, il monumento a Vincenzo Errante, letterato e patriota, eseguito nel 1897 da Pasquale Civiletti, e il monumento a Giovanni Ramondetta di Gerardo Scudo su modello di Giacomo Serpotta (1691). Nella adiacente cappella d'ingresso meridionale è l'imponente monumento allo statista Francesco Crispi. La cappella a destra dell'altare maggiore contiene due rilievi, la Pietà e S. Caterina, di Antonello Gagini, ed il monumento a Domenico Lo Faso, archeologo, architetto e studioso, di Benedetto De Lisi (1864); sull'altare è un Crocifisso ligneo.
Il settecentesco altare maggiore è cinto da una balaustra curvilinea in marmi mischi. Posta su gradinata in marmo rosso dall'elegante disegno, la mensa è realizzata in marmi vari e pietre semipreziose e completato da vasotti; alle spalle dell'altare è il coro in legno intagliato. Tra i pilastri laterali sono poste due bellissime cantorie barocche in legno intagliato e dorato con eleganti transenne concluse da fregi rococò.
Nella chiesa si conserva un telone, alto quanto la navata centrale, dipinto a monocromi con disegno barocco della Crocifissione che viene esposto durante la Settimana Santa nella tribuna e che un tempo veniva fatto cadere con gran fragore durante la liturgia della notte di Pasqua
(A calata ra tila).
Alla sinistra dell'altare maggiore è la cappella del S. Cuore in cui sono custoditi il sarcofago di Michele Amari, studioso di storia siciliana e uomo politico, opera di Giuseppe Patricolo in stile neonormanno (inizio XX secolo), ed il monumento a padre Luigi Di Maggio di Salvatore Valenti (1902) in stile classico-rinascimentale; all'ingresso sono due bassorilievi di scuola gaginesca.
All'altare del transetto di sinistra, simile all'opposto, è posta la tela della "Madonna del Rosario" di Vincenzo da Pavia 1540; nello stesso cappellone sono i monumenti a Michele e Domenico Scavo, di Ignazio Marabitti, e la stele ad Emanuele Bellia, di B. De Lisi (1861). La cappella dell'ingresso laterale è dedicata a S. Giacinto di Polonia; sull'altare è un dipinto su lavagna di scuola fiamminga. Lateralmente si trovano: il monumento a Ruggero Settimo, presidente del Parlamento Siciliano rivoluzionario del 1848, di S. Valenti e D. Costantino (1865), ed il monumento a Vito La Mantia, giureconsulto e studioso del diritto siciliano, di Mario Rutelli (1912).
Nella navata sinistra, oltre il transetto, la sesta cappella è dedicata a S. Rosa da Lima con tela di Girolamo di Fiandra (XVIII secolo). Segue la cappella Di Benedetto, dove si segnala tra le altre sepolture quella di Raffaele di Benedetto, scolpita da B. De Lisi nel 1870. La quarta cappella ha altare in marmi e stucchi, quindi è l'accesso al chiostro. Tra la seconda e la terza cappella è il bel monumento funebre, in stile liberty (1904), a Francesco Paolo Perez, politico e letterato, sindaco di Palermo e ministro nel 1877. Sull'altare della seconda cappella è la statua in terracotta di S. Caterina da Siena, di scuola siciliana (XVI secolo). Il primo monumento vicino all’ıngresso è dedicato a Francesco Ferrara, statista ed economista.
Il convento di S. Domenico si estendeva a settentrione della chiesa ed occupava un vastissimo isolato tra le vie Gagini, ad occidente, via Valverde a nord, via Bambinai e largo Cavalieri di Malta ad oriente, e confinava col monastero di Valverde. Questa grande area comprendeva, oltre al chiostro trecentesco, altre due corti di maggiori dimensioni, di cui uno, con accesso da via Bambinai, ancor oggi visibile; il secondo cortile è stato varie volte trasformato ed oggi è circondato da abitazioni private. Nei locali del convento avevano sede, fin dal XV secolo, una scuola di Filosofia e Teologia, una fornitissima biblioteca, ancor oggi fruibile, e l'Accademia degli Accesi, fondata nella seconda metà del XVI secolo. II convento fu inoltre la prima sede cittadina del Tribunale dell’Inquisizione, istituito nel 1261.
Il chiostro trecentesco conserva tre delle originarie corsie sostenute da coppie di colonnine binate ed archi ogivali, dove sono parzialmente visibili affreschi dei secoli XV e XVI. Vi ha sede dal 1873 la Società Siciliana di Storia Patria, istituita nel 1863 in ricordo delle imprese risorgimentali; alla realizzazione dell'istituto hanno collaborato insigni studiosi, intellettuali e politici siciliani; al suo interno sono il Museo del Risorgimento, inaugurato nel 1918, con una raccolta di cimeli e documenti garibaldini, ed una biblioteca che raccoglie in più di 250.000 volumi di scritti storici sulla Sicilia. Restaurato nel dopoguerra e riaperto nel 1961, il museo è oggi punto di riferimento di molti studiosi; è inoltre attivo centro di promozione culturale.
48 Recomendado por los habitantes de la zona
Chiesa di San Domenico
Piazza San DomenicoDalla metà del XIX secolo, nella chiesa di San Domenico è accolto il Pantheon degli Illustri di Sicilia, uomini e donne distinti per meriti più variegati: letterati, giuristi, artisti, poeti, personalità di importanza civile e politica.
In chiesa si possono ammirare lapidi, tombe, cenotafi e targhe che ne commemorano il ricordo.
Nel 2015 la comunità dei frati Predicatori del convento di San Domenico di Palermo si è fatta promotrice della realizzazione di un monumento funebre per il magistrato Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia insieme alla moglie e alla sua scorta il 23 maggio 1992. Dal 23 marzo 2024 riposa a San Domenico anche il grande scrittore siciliano di fama mondiale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore di uno dei romanzi più fortunati della narrativa italiana del secolo XX "Il Gattopardo", tradotto in tutte le lingue del mondo.
Il Pantheon continua ad essere un luogo vivo della memoria e dell’identità dei siciliani; un luogo in cui ad essere commemorati siano uomini che con il loro impegno – e nel caso di Giovanni Falcone sino al sacrificio della propria vita – hanno contribuito al riscatto della nostra terra.
La monumentale chiesa di San Domenico, costruita in questa forma a partire dal 1640, è anche il Pantheon degli uomini illustri di Sicilia: nelle tre navate della sua imponente architettura barocca trovano riposo il grande storico del Vespro siciliano e degli Arabi in Sicilia, Michele Amari (1806-1889); il poeta Giovanni Meli (1740-1815), vero e proprio corifeo della poesia dialettale del '700 palermitano; l'appassionato cultore di storia palermitana universalmente noto come il marchese di Villabianca (1720-1802); il più grande studioso delle tradizioni popolari siciliane, Giuseppe Pitré (1841-1916); il chimico Stanislao Cannizzaro (1826-1910) e, dopo innumerevoli altri che hanno dato dignità e onore a tutta la Sicilia, nel 2015 sono state traslate a San Domenico le spoglie del giudice palermitano Giovanni Falcone, ucciso barbaramente dalla mafia nel 1992. Nel 2019 ha qui trovato riposo l'archeologo marino Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso in un incidente aereo.
I Domenicani, giunti a Palermo già nel 1216, furono dapprima ospitati nel monastero di S. Matteo al Cassaro, nell'area dell’odierno monastero di S. Caterina, rimasto vuoto dopo il trasferimento delle monache basiliane al monastero del Ss. Salvatore.
A partire dal 1300 fu decisa l'edificazione del nuovo e più grande complesso conventuale, per il quale fu scelta quest'area risultante dal progressivo interramento del porto. Appartengono alla primitiva costruzione le tre corsie superstiti del chiostro, sulla sinistra della chiesa attuale.
La chiesa di S. Domenico venne quasi totalmente rifatta nel 1458 (di questa seconda edificazione non rimangono che alcuni tratti murari della tribuna), ed infine nel 1640, quando i padri Domenicani vollero ingrandirla. Il nuovo edificio risultò tanto ampio da sacrificare la corsia meridionale del chiostro ed occupare parte della piazza antistante. Per la costruzione delle prime due cappelle di destra fu pure demolita la cappella di S. Orsola che insisteva sull'attuale via Meli.
Il luogo in cui sorgeva il complesso conventuale, infatti, era divenuto, in tre secoli, un fitto intrigo di vicoli molto animati per via della vicinanza col porto e con le attrezzature mercantili della zona. La strada su cui la chiesa prospettava (identificabile col proseguimento della via Gagini) formava uno slargo proprio in corrispondenza della chiesa. Nel 1724, quando venne data sistemazione alla piazza, anche la facciata della chiesa ebbe una nuova veste. Questa, infatti, nel progetto originario seicentesco non prevedeva il grandioso telaio di colonne straccato dal paramento che invece fu realizzato. È probabile che la scelta sia stata influenzata da altri esempi palermitani, come la vicina chiesa di S. Ignazio o quella della Pietà, tuttavia, in questo caso risultò maggiore lo sviluppo orizzontale. I lavori della facciata si protrassero per circa 50 anni sotto la direzione di diversi architetti, tra cui Tomaso Maria Napoli, Andrea Palma, che si dedicò ai lavori del campanile destro, Giovanni Biagio Amico, Cosimo Agnetta e Lorenzo Olivier. Coppie di colonne, aggettanti rispetto al filo murario, dividono il prospetto in tre partiti; le colonne proseguono nel secondo ordine solo nel
partito centrale, mentre i laterali sono animati da nicchie e dalle statue dei papi domenicani. La pagina muraria risulta mossa dalle cromie degli stucchi, realizzati nel 1756 da Giovanni Maria Serpotta, e dalle statue che si stagliano contro il fondo trattato ad intonaco. L'insieme prende slancio verticale coi due campanili laterali, uniti al frontone curvilineo da due aeree balaustre.
La stesura complessiva della chiesa è seicentesca. Il progetto viene attribuito secondo alcuni ad Andrea Cirrincione, secondo altri a Vincenzo Tedesco. La pianta è a croce latina con ampie navate ed esteso transetto; la profonda tribuna termina con un catino semicircolare. L'interno, privo di ornamenti, fu completato intorno al 1690 e deve la sua eccezionale eleganza alle classiche e solenni forme architettoniche, e si arricchisce delle opere d'arte contenute nelle cappelle. Alcune di queste sono state riccamente ornate da altari in marmo, pitture e stucchi nel XVIII secolo.
Dal XIX secolo vi hanno trovato sepoltura gli uomini più illustri della città e la chiesa è considerata il “pantheon" di Palermo. Le sepolture ed i monumenti sono segnalati da apposite targhe, pertanto, vengono qui indicati solo i principali. Lateralmente all'ingresso sono due acquasantiere con rilievi del XV secolo. La prima cappella della navata destra è intitolata alla Madonna di Lourdes; vi è posto il monumento funebre di Emanuele Emanuele Gaetani, marchese di Villabianca, erudito e storico delle vicende cittadine, eseguito da Leonardo Pennino nel 1802 con rilievo della Trinacria. La terza cappella, Interamente ricoperta in marmi mischi, è la sepoltura della famiglia Oneto di Sperlinga; sull’altare, con colonne tortili, è la statua di s. Giuseppe di Antonello Gagini; alle pareti sono stucchi e puttini in rilievo. Ai lati sono due monumenti funebri in marmi mischi, perfettamente armonizzati alle decorazioni parietali: a destra quello di Marianna Oneto Monroy, a sinistra quello di Giacomo Majorca, conte di Francavilla. Segue la cappella dedicata a S. Anna con tela di Rosalia Novelli (XVII sec.), tra due belle statue muliebri; l'altare ha cornici in marmi mischi; ai lati due sarcofagi del XVII secolo, in marmi mischi come la balaustra. Nella quinta cappella è il monumento funebre ad Emerico Amari, eseguito da Domenico Costantino nel 1875; il patriota e giurista palermitano è raffigurato su una seggiola posta su un'alta ara, in cui è un rilievo marmoreo. Lateralmente sono i monumenti a Gaetano Daita, letterato e poeta, di Vincenzo La Parola (1903), ed a Salvatore Vico Patania, di Benedetto Civiletti (1877). La successiva cappella, preceduta da una bella balaustra curvilinea, ha altare in marmi policromi e timpano mistilineo spezzato con marmo e piatte paraste in marmo rosso e giallo; ai lati sono due sarcofagi; alle pare
ti è realizzata a fresco un'architettura fittizia.
Il transetto ha analoghi altari realizzati nel 1758 secondo un solenne ed articolato disegno di padre Lorenzo Olivier: coppie di colonne sfalzate sorreggono timpani mistilinei spezzati che culminano centro in stemmi sorretti da angeli; le decorazioni sono in marmi vari, i capitelli estremamente lavorati e le cornici doppie. Gli altari hanno volute laterali e fregi in bronzo e sono preceduti da balaustre in marmi mischi. L'altare di destra è dedicato a S. Domenico, con tela di Filippo Paladini; sulle pareti laterali sono vari altari e monumenti tra questi, il monumento a Vincenzo Errante, letterato e patriota, eseguito nel 1897 da Pasquale Civiletti, e il monumento a Giovanni Ramondetta di Gerardo Scudo su modello di Giacomo Serpotta (1691). Nella adiacente cappella d'ingresso meridionale è l'imponente monumento allo statista Francesco Crispi. La cappella a destra dell'altare maggiore contiene due rilievi, la Pietà e S. Caterina, di Antonello Gagini, ed il monumento a Domenico Lo Faso, archeologo, architetto e studioso, di Benedetto De Lisi (1864); sull'altare è un Crocifisso ligneo.
Il settecentesco altare maggiore è cinto da una balaustra curvilinea in marmi mischi. Posta su gradinata in marmo rosso dall'elegante disegno, la mensa è realizzata in marmi vari e pietre semipreziose e completato da vasotti; alle spalle dell'altare è il coro in legno intagliato. Tra i pilastri laterali sono poste due bellissime cantorie barocche in legno intagliato e dorato con eleganti transenne concluse da fregi rococò.
Nella chiesa si conserva un telone, alto quanto la navata centrale, dipinto a monocromi con disegno barocco della Crocifissione che viene esposto durante la Settimana Santa nella tribuna e che un tempo veniva fatto cadere con gran fragore durante la liturgia della notte di Pasqua
(A calata ra tila).
Alla sinistra dell'altare maggiore è la cappella del S. Cuore in cui sono custoditi il sarcofago di Michele Amari, studioso di storia siciliana e uomo politico, opera di Giuseppe Patricolo in stile neonormanno (inizio XX secolo), ed il monumento a padre Luigi Di Maggio di Salvatore Valenti (1902) in stile classico-rinascimentale; all'ingresso sono due bassorilievi di scuola gaginesca.
All'altare del transetto di sinistra, simile all'opposto, è posta la tela della "Madonna del Rosario" di Vincenzo da Pavia 1540; nello stesso cappellone sono i monumenti a Michele e Domenico Scavo, di Ignazio Marabitti, e la stele ad Emanuele Bellia, di B. De Lisi (1861). La cappella dell'ingresso laterale è dedicata a S. Giacinto di Polonia; sull'altare è un dipinto su lavagna di scuola fiamminga. Lateralmente si trovano: il monumento a Ruggero Settimo, presidente del Parlamento Siciliano rivoluzionario del 1848, di S. Valenti e D. Costantino (1865), ed il monumento a Vito La Mantia, giureconsulto e studioso del diritto siciliano, di Mario Rutelli (1912).
Nella navata sinistra, oltre il transetto, la sesta cappella è dedicata a S. Rosa da Lima con tela di Girolamo di Fiandra (XVIII secolo). Segue la cappella Di Benedetto, dove si segnala tra le altre sepolture quella di Raffaele di Benedetto, scolpita da B. De Lisi nel 1870. La quarta cappella ha altare in marmi e stucchi, quindi è l'accesso al chiostro. Tra la seconda e la terza cappella è il bel monumento funebre, in stile liberty (1904), a Francesco Paolo Perez, politico e letterato, sindaco di Palermo e ministro nel 1877. Sull'altare della seconda cappella è la statua in terracotta di S. Caterina da Siena, di scuola siciliana (XVI secolo). Il primo monumento vicino all’ıngresso è dedicato a Francesco Ferrara, statista ed economista.
Il convento di S. Domenico si estendeva a settentrione della chiesa ed occupava un vastissimo isolato tra le vie Gagini, ad occidente, via Valverde a nord, via Bambinai e largo Cavalieri di Malta ad oriente, e confinava col monastero di Valverde. Questa grande area comprendeva, oltre al chiostro trecentesco, altre due corti di maggiori dimensioni, di cui uno, con accesso da via Bambinai, ancor oggi visibile; il secondo cortile è stato varie volte trasformato ed oggi è circondato da abitazioni private. Nei locali del convento avevano sede, fin dal XV secolo, una scuola di Filosofia e Teologia, una fornitissima biblioteca, ancor oggi fruibile, e l'Accademia degli Accesi, fondata nella seconda metà del XVI secolo. II convento fu inoltre la prima sede cittadina del Tribunale dell’Inquisizione, istituito nel 1261.
Il chiostro trecentesco conserva tre delle originarie corsie sostenute da coppie di colonnine binate ed archi ogivali, dove sono parzialmente visibili affreschi dei secoli XV e XVI. Vi ha sede dal 1873 la Società Siciliana di Storia Patria, istituita nel 1863 in ricordo delle imprese risorgimentali; alla realizzazione dell'istituto hanno collaborato insigni studiosi, intellettuali e politici siciliani; al suo interno sono il Museo del Risorgimento, inaugurato nel 1918, con una raccolta di cimeli e documenti garibaldini, ed una biblioteca che raccoglie in più di 250.000 volumi di scritti storici sulla Sicilia. Restaurato nel dopoguerra e riaperto nel 1961, il museo è oggi punto di riferimento di molti studiosi; è inoltre attivo centro di promozione culturale.
La Compagnia del SS. Rosario fu istituita nel 1568 ed accoglieva, fra gli altri, il ceto più abbiente tra artigiani e commercianti; tra i confrati furono Pietro Novelli e Giacomo Serpotta che vi hanno lasciato importantissime opere. La Compagnia utilizzava inizialmente l'oratorio di S. Orsola a S. Domenico, oggi non più esistente; qualche anno più tardi (1573), ad opera del confrate Giuseppe Giacalone, venne sistemato questo oratorio che divenne, anche per l'opera di altri confrati, uno dei più eleganti e ricchi d'arte della città. Il cappellone fu terminato nel 1627, con l'acquisto di un lotto limitrofo. Nei primi anni del '700 fu eseguita la decorazione in stucco. L'aula dell'oratorio costituisce il culmine dell'arte decorativa tipica di queste costruzioni ed un “unicum” nel genere degli oratori; infatti, oltre alla splendida decorazione a stucco che vi produsse Giacomo Serpotta, l'aula è una vera galleria della pittura seicentesca poiché raccoglie tele di autori fiamminghi, genovesi, italiani e siciliani e di scuola caravaggesca.
Superato il classico portale d’ingresso, eseguito nell'ultimo ventennio del XVIII secolo su progetto di Vincenzo Fiorelli, si accede ad un antioratorio rettangolare con decorazioni neoclassiche, soffitto volta ribassata e lacunari esagonali. Nella controparete di facciata è un portale barocco. Questo ambiente si conclude con l'altare del Crocifisso, con Crocifisso ligneo del XVIII secolo e reliquario, posto in un'edicola classica. Dalle due porte del lato destro si accede alla sala dell'oratorio, disposto ortogonalmente al vestibolo. La sala rettangolare ha un piccolo cappellone retto. Alle pareti si snoda la sequenza delle pitture, eseguite nella prima metà del '600 da vari pittori, con la raffigurazione dei Misteri del SS. Rosario, alternate alle sculture delle Virtù cristiane, approntate da Giacomo Serpotta.
Nella fascia superiore, ai lati delle finestre, sono medaglioni in stucco con “Storie della Genesi e dell'Apocalisse”, retti da putti. Sulla parete d'ingresso sono: la "Resurrezione", l'“Ascensione", la "Discesa dello Spirito Santo", di Pietro Novelli, l'Ascensione della Vergine" e "S. Caterina”. Sulla parete di destra sono: l'"Orazione nell'orto", la "Flagellazione” di Mattia Stomer, la "Coronazione di spine" e la "Salita al Calvario" di artisti fiamminghi e la "Crocifissione" di scuola di Van Dyck.
Sulla parete opposta sono: l'Annunciazione, di Giacomo Lo Verde, la "Visitazione" di Guglielmo Borremans, eseguita verso la fine del terzo decennio del '700, la "Natività e la "Presentazione al tempio" di scuola di Pietro Novelli e la “Disputa tra i dottori dello stesso Novelli.
L'ovale al centro della volta fu affrescato da Pietro Novelli nel 1628 con l'Incoronazione della Vergine; i quattro piccoli affreschi agli angoli furono aggiunti da G. Borremans nel '700. La decorazione scultorea riveste con armonia ed organicità le pareti lasciate libere dalle pitture; un vasto repertorio scultoreo anima la semplice aula, con figure di putti, dame, cavalieri, tutte perfettamente definite con dovizia di particolari e disposte con magistrale eleganza a fondersi in un unico organismo compositivo. A queste si alternano le statue delle dodici Virtù, vero capolavoro serpottiano in cui si rivela la vena ormai classica dell'autore. Sulla seconda allegoria del lato destro è la firma del Serpotta, costituita da una lucertola o piccola serpe".
La sala ha elegante pavimento in maiolica a mattonelle bianche e nere. Il presbiterio è introdotto dall'arco trionfale affiancato dalle statue della Giustizia (destra) e Sapienza (sinistra). L'arco è sormontato da un drappo in funzione di cartiglio. Sull'altare è la “Madonna e Santi" dipinta da Antonio Van Dyck nel 1628. Quest'opera, dalla quale furono tratte molte copie, ebbe una grande influenza nella pittura siciliana del XVII secolo e rappresento il genere più apprezzato per gli oratori di compagnie facoltose che facevano a gara per aggiudicarsi le opere degli artisti più rinomati e meglio pagati. Alla pala si affiancano le statue della Grazia e della Provvidenza. Il presbiterio e coperto da fantasioso cupolino decorato da stucchi con una teoria di piccole figure affacciate.
(Fonte: A. Chirco, Palermo: La città ritrovata : Itinerari entro le mura. 3 ed. Palermo : D. Flaccovio, 2005)
6 Recomendado por los habitantes de la zona
Oratorio del Santissimo Rosario in San Domenico
2 Via BambinaiLa Compagnia del SS. Rosario fu istituita nel 1568 ed accoglieva, fra gli altri, il ceto più abbiente tra artigiani e commercianti; tra i confrati furono Pietro Novelli e Giacomo Serpotta che vi hanno lasciato importantissime opere. La Compagnia utilizzava inizialmente l'oratorio di S. Orsola a S. Domenico, oggi non più esistente; qualche anno più tardi (1573), ad opera del confrate Giuseppe Giacalone, venne sistemato questo oratorio che divenne, anche per l'opera di altri confrati, uno dei più eleganti e ricchi d'arte della città. Il cappellone fu terminato nel 1627, con l'acquisto di un lotto limitrofo. Nei primi anni del '700 fu eseguita la decorazione in stucco. L'aula dell'oratorio costituisce il culmine dell'arte decorativa tipica di queste costruzioni ed un “unicum” nel genere degli oratori; infatti, oltre alla splendida decorazione a stucco che vi produsse Giacomo Serpotta, l'aula è una vera galleria della pittura seicentesca poiché raccoglie tele di autori fiamminghi, genovesi, italiani e siciliani e di scuola caravaggesca.
Superato il classico portale d’ingresso, eseguito nell'ultimo ventennio del XVIII secolo su progetto di Vincenzo Fiorelli, si accede ad un antioratorio rettangolare con decorazioni neoclassiche, soffitto volta ribassata e lacunari esagonali. Nella controparete di facciata è un portale barocco. Questo ambiente si conclude con l'altare del Crocifisso, con Crocifisso ligneo del XVIII secolo e reliquario, posto in un'edicola classica. Dalle due porte del lato destro si accede alla sala dell'oratorio, disposto ortogonalmente al vestibolo. La sala rettangolare ha un piccolo cappellone retto. Alle pareti si snoda la sequenza delle pitture, eseguite nella prima metà del '600 da vari pittori, con la raffigurazione dei Misteri del SS. Rosario, alternate alle sculture delle Virtù cristiane, approntate da Giacomo Serpotta.
Nella fascia superiore, ai lati delle finestre, sono medaglioni in stucco con “Storie della Genesi e dell'Apocalisse”, retti da putti. Sulla parete d'ingresso sono: la "Resurrezione", l'“Ascensione", la "Discesa dello Spirito Santo", di Pietro Novelli, l'Ascensione della Vergine" e "S. Caterina”. Sulla parete di destra sono: l'"Orazione nell'orto", la "Flagellazione” di Mattia Stomer, la "Coronazione di spine" e la "Salita al Calvario" di artisti fiamminghi e la "Crocifissione" di scuola di Van Dyck.
Sulla parete opposta sono: l'Annunciazione, di Giacomo Lo Verde, la "Visitazione" di Guglielmo Borremans, eseguita verso la fine del terzo decennio del '700, la "Natività e la "Presentazione al tempio" di scuola di Pietro Novelli e la “Disputa tra i dottori dello stesso Novelli.
L'ovale al centro della volta fu affrescato da Pietro Novelli nel 1628 con l'Incoronazione della Vergine; i quattro piccoli affreschi agli angoli furono aggiunti da G. Borremans nel '700. La decorazione scultorea riveste con armonia ed organicità le pareti lasciate libere dalle pitture; un vasto repertorio scultoreo anima la semplice aula, con figure di putti, dame, cavalieri, tutte perfettamente definite con dovizia di particolari e disposte con magistrale eleganza a fondersi in un unico organismo compositivo. A queste si alternano le statue delle dodici Virtù, vero capolavoro serpottiano in cui si rivela la vena ormai classica dell'autore. Sulla seconda allegoria del lato destro è la firma del Serpotta, costituita da una lucertola o piccola serpe".
La sala ha elegante pavimento in maiolica a mattonelle bianche e nere. Il presbiterio è introdotto dall'arco trionfale affiancato dalle statue della Giustizia (destra) e Sapienza (sinistra). L'arco è sormontato da un drappo in funzione di cartiglio. Sull'altare è la “Madonna e Santi" dipinta da Antonio Van Dyck nel 1628. Quest'opera, dalla quale furono tratte molte copie, ebbe una grande influenza nella pittura siciliana del XVII secolo e rappresento il genere più apprezzato per gli oratori di compagnie facoltose che facevano a gara per aggiudicarsi le opere degli artisti più rinomati e meglio pagati. Alla pala si affiancano le statue della Grazia e della Provvidenza. Il presbiterio e coperto da fantasioso cupolino decorato da stucchi con una teoria di piccole figure affacciate.
(Fonte: A. Chirco, Palermo: La città ritrovata : Itinerari entro le mura. 3 ed. Palermo : D. Flaccovio, 2005)
L'oratorio e le sale d esso attigue furono costruiti nella seconda metà del XVII secolo dalla Compagnia del Rosario, fondata nel 1570 presso il convento dei Domenicani riformati dal B. Pietro Geremia.
"Nell'oratorio le statue del Serpotta dialogano con la luce con movimenti ora appena accennati, ora diretti e sostenuti; il ritmo e l'incalzare delle scene rende partecipe lo spettatore del mistero che vi si celebra in un vortice di seduzione mistica, che non ha però nulla di estatico, anzi è pervaso d una sensibilità tutta terrena ed attuale nel rincorrersi delle figure di popolane e fanciulli. Seppure ispirate dall'elegante disegno barocco, l'esuberanza e la drammaticità delle scene indicano una straordinaria ricerca di attualità: l'impressione è che le figure, poste in posizione dominante e realizzate con grande naturalità di sembianze e gesti, più che rappresentare virtù e beatitudini, siano in realtà la raffigurazione dell'intero popolo delle strade di Palermo, spettatore delle celebrazioni che si svolgono all'interno, vera scena di questo tormentato teatro barocco."
(Tratto da: A. Chirco, Palermo la città ritrovata. Palermo, D. Flaccovio, 2005)
53 Recomendado por los habitantes de la zona
Oratorio di Santa Cita
3 Via ValverdeL'oratorio e le sale d esso attigue furono costruiti nella seconda metà del XVII secolo dalla Compagnia del Rosario, fondata nel 1570 presso il convento dei Domenicani riformati dal B. Pietro Geremia.
"Nell'oratorio le statue del Serpotta dialogano con la luce con movimenti ora appena accennati, ora diretti e sostenuti; il ritmo e l'incalzare delle scene rende partecipe lo spettatore del mistero che vi si celebra in un vortice di seduzione mistica, che non ha però nulla di estatico, anzi è pervaso d una sensibilità tutta terrena ed attuale nel rincorrersi delle figure di popolane e fanciulli. Seppure ispirate dall'elegante disegno barocco, l'esuberanza e la drammaticità delle scene indicano una straordinaria ricerca di attualità: l'impressione è che le figure, poste in posizione dominante e realizzate con grande naturalità di sembianze e gesti, più che rappresentare virtù e beatitudini, siano in realtà la raffigurazione dell'intero popolo delle strade di Palermo, spettatore delle celebrazioni che si svolgono all'interno, vera scena di questo tormentato teatro barocco."
(Tratto da: A. Chirco, Palermo la città ritrovata. Palermo, D. Flaccovio, 2005)
Costruita nel 1586 su una preesistente chiesa del trecento dedicata alla Santa toscana, S. Zita con annesso ospedale, che divenne convento domenicano intorno al XV secolo. Accanto alla piccola chiesa trecentesca, nel 1458 venne eretta una seconda chiesa; ambedue vennero demolite per la costruzione dell’attuale grande edificio ecclesiale, cominciato nel 1586. La nuova chiesa, eretta su progetto di Giuseppe Giacalone in solenni forme tardo-rinascimentali, fu aperta nel 1603.
Dopo il secondo conflitto mondiale, l’edificio ha subito delle notevoli demolizioni, cambiando notevolmente la sua struttura. In quel periodo la chiesa venne adattata ad altri usi, tra cui quello di deposito di derrate alimentari ed aula di Tribunale. Riaperta dopo la guerra e dedicata a S. Mamiliano vi rimangono la grande navata centrale ed il largo transetto, oltre il quale si aprono cinque cappelle, tra cui il cappellone centrale con profondo coro. Fortunatamente, splendidi affreschi ed interessanti opere d’arte realizzate da illustri artisti, come: Antonio Grano, Antonello Gagini, Filippo Paladini etc. si sono conservati.
Di notevole interesse è la Cappella di Maria SS. Del Rosario, splendido esempio di decorazione a marmi mischi. La cappella, la cui definizione si protrasse dal 1696 al 1722, è interamente ricoperta da pannelli in marmo disegnato ad intaglio in cui sono contenuti i dieci Misteri del Rosario, scolpiti da Gioacchino Vitagliano; di eccezionale fattura è il paliotto dell’altare, con incrostazioni di pietre semipreziose, ed il pavimento, costituito da lapidi sepolcrali variamente lavorate.
Chiesa di San Mamiliano
1 Via SquarcialupoCostruita nel 1586 su una preesistente chiesa del trecento dedicata alla Santa toscana, S. Zita con annesso ospedale, che divenne convento domenicano intorno al XV secolo. Accanto alla piccola chiesa trecentesca, nel 1458 venne eretta una seconda chiesa; ambedue vennero demolite per la costruzione dell’attuale grande edificio ecclesiale, cominciato nel 1586. La nuova chiesa, eretta su progetto di Giuseppe Giacalone in solenni forme tardo-rinascimentali, fu aperta nel 1603.
Dopo il secondo conflitto mondiale, l’edificio ha subito delle notevoli demolizioni, cambiando notevolmente la sua struttura. In quel periodo la chiesa venne adattata ad altri usi, tra cui quello di deposito di derrate alimentari ed aula di Tribunale. Riaperta dopo la guerra e dedicata a S. Mamiliano vi rimangono la grande navata centrale ed il largo transetto, oltre il quale si aprono cinque cappelle, tra cui il cappellone centrale con profondo coro. Fortunatamente, splendidi affreschi ed interessanti opere d’arte realizzate da illustri artisti, come: Antonio Grano, Antonello Gagini, Filippo Paladini etc. si sono conservati.
Di notevole interesse è la Cappella di Maria SS. Del Rosario, splendido esempio di decorazione a marmi mischi. La cappella, la cui definizione si protrasse dal 1696 al 1722, è interamente ricoperta da pannelli in marmo disegnato ad intaglio in cui sono contenuti i dieci Misteri del Rosario, scolpiti da Gioacchino Vitagliano; di eccezionale fattura è il paliotto dell’altare, con incrostazioni di pietre semipreziose, ed il pavimento, costituito da lapidi sepolcrali variamente lavorate.
Ubicata in piazza San Giacomo la Marina, nell’antica contrada della “Tavola Tonda al Castellamare” (così chiamata per la presenza, un tempo, di numerosi fondaci e locande), tra il vecchio mercato della Vucciria e l’antico porto della Cala, la Chiesa di Santa Maria La Nova nacque dalla trasformazione di un oratorio annesso ad un’ospedale per la cura dei pellegrini eretto nel 1339 poi diventato Casa di Disciplina.
Nella stessa piazza, fino al 1860, quando se ne decretò la demolizione a seguito dei danneggiamenti causati dalle cannoniere borboniche durante i moti palermitani, esisteva l’antica chiesa di San Giacomo la Marina, fondata in epoca normanna, probabilmente dalla trasformazione di una moschea araba, anche se questa tesi non è suffragata da fonti documentarie certe, e quei pochi indizi di cui siamo in possesso dovrebbero essere verificati e approfonditi.
La nuova edificazione (da qui la denominazione di “Nova”) fu decisa dalla Confraternita di Santa Maria la Nova attorno al 1520 (pare a seguito di un evento ritenuto miracoloso), anche se la costruzione, nel cui cantiere lavorarono i “maestri fabbricatori” Giuseppe Spatafora e Giuseppe Giacalone, si protrasse per diversi decenni (fu compiuta nelle sue strutture principali almeno, nel 1582).
Nel 1585 vi fu istituita la Deputazione per la Redenzione dei Cattivi (dal latino captivi, cioè prigionieri), che aveva come compito istituzionale la raccolta delle elemosine per il riscatto degli schiavi cristiani fatti prigionieri dai turchi.
Il sacro edificio, durante l’ultimo conflitto mondiale, come tanti altri monumenti della città, veniva danneggiato in una incursione aerea nemica avvenuta nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo 1943. Gli effetti della deflagrazione di un ordigno caduto nelle sue vicinanze causarono il crollo del tetto del tiburio, e alcuni danni, per fortuna di poca entità, all’interno e agli infissi.
La chiesa di Santa Maria la Nova detiene il titolo parrocchiale e ha sempre svolto un ruolo di rilievo, sia nelle vicende religiose che in quelle economiche-sociali del quartiere della “Loggia” che fino alla metà del Novecento fu il centro del cuore economico della città.
Per quanto riguarda la configurazione esterna, questo edificio religioso rappresenta un mirabile esempio di architettura della prima metà del sec. XVI, testimonianza emblematica dell’architettura cinquecentesca a Palermo, ancora incentrata sull’evidente adesione a schemi di gusto Gotico-Catalano, a lungo presenti nell’architettura palermitana.
Di notevole importanza è l’elegante portico con loggiato il “Tocco”, sempre presente nelle chiese dei quartieri mercantili, che ingentilisce la facciata principale e precede l’ingresso alla chiesa.
Rinserrato fra due piloni angolari caratterizzati da aperture cieche che creano un plastico gioco di sporgenze, presenta tre arcate a mezzo sesto con ghiere a rincasso sorrette da due colonne in marmo con capitelli corinzi finemente lavorati.
La copertura del portico è costituita da volte a crociera costolonate con chiavi pendule, elementi riconoscibili della tradizione Gotico-Catalano: il loggiato è chiuso da una cancellata in ferro battuto.
L’osservatore attento non potrà fare a meno di notare che la facciata, nella sua parte superiore, si differenzia notevolmente dalla parte inferiore sia nello stile che nella muratura. Questa situazione deriva dagli interventi, piuttosto significativi, che interessarono l’edificio religioso nella prima metà dell’ottocento, dove è stato interamente realizzato in stile neogotico l’ordine superiore della facciata. Questo secondo ordine scandito da leggere paraste e chiuso da una cornicione con eleganti figurazioni scultoree a motivi “conchiliformi”, racchiude un oratorio della fine del XVI secolo di cui, sul lato sinistro, rimane una finestra dell’epoca; il risultato è tutto sommato, gradevole.
Si accede alla chiesa da un piccolo portale architravato sormontato da un medaglione in stucco dove è rappresentata la stella a otto punte simbolo della “Vergine”.
Nella parete di controfacciata, in una nicchia sopra il portale si trova una statua di Sant’Alessio protettore dei mendicanti.
L’architettura interna, di ordine corinzio, risulta molto pacata nel suo apparato ordinale di lesene che legano in modo sintatticamente corretto le pareti delle navate laterali con le volte. L’aula basilicale a triplice navata senza transetto di scuola gaginesca è caratterizzata da archi a pieno sesto che poggiano su colonne monolite con eleganti capitelli corinzi dove, una modesta illuminazione naturale che penetra appena dalle alte finestre laterali, crea suggestioni particolari.
Presenta pregevoli addobbi di stucchi settecenteschi, gustosamente distribuiti attribuiti a Procopio Serpotta. La tribuna ottagona con cupola, progettata dal piemontese Giorgio Di Faccio, di impianto centrico, è di chiaro stile rinascimentale.
Le navate laterali sono fiancheggiate da “rientranze” ricavate dallo spessore dei muri su entrambi i lati (solo una, la seconda di destra, è una cappella profonda, intitolata a Santa Maria la Nova) dove, anche se purtroppo molte sono state trafugate, si possono ammirare ancora opere d’arte di notevole interesse e valore artistico .
Il pavimento in marmo della navata centrale con stelle ad otto punte, che rimanda simbolicamente alla Vergine, è opera novecentesca realizzata su disegno di Francesco Paolo Palazzotto.
Lato destro
La prima nicchia a destra dell’ingresso custodisce una pregevole tela settecentesca di Carmelo Salpietra che raffigura “l’Angelo custode”.
Degna di nota la cappella che segue intitolata a Santa Maria la Nova, come dicevo l’unica cappella vera e propria. Sulla volta troviamo pregevoli affreschi che raffigurano la Vergine con i quattro Evangelisti.
Alle pareti tre elaborati monumenti funebri d’ispirazione manierista appartenenti alla nobile famiglia Giancardo, che un tempo deteneva il patrocinio della cappella, e sull’altare un dipinto settecentesco di notevole interesse che raffigura “La Madonna con Gesù e Santi” di Antonio Manno, allievo del più celebre pittore Vito D’Anna.
Nella cappella, entrando a destra, è custodito un dipinto su ardesia del tardo cinquecento che raffigura Cristo e la Vergine.
Nella nicchia successiva si trova un magnifico dipinto del 1774 ancora di Antonio Manno intitolato “Il Transito della Vergine”.
Successivamente troviamo l’ingresso alla sacrestia sormontato da un elegante balconcino di gusto rococò in funzione di cantoria.
Nell’ultima nicchia della navata si trova un monumento funebre in marmo.
Proseguendo arriviamo alla prima cappelletta dell’emiciclo destro della tribuna dove è collocato un dipinto che raffigura la Madonna del Lume del pittore Luigi Lo Jacono del 1883 con ai piedi un fonte battesimale.
Andando avanti troviamo un piccolo altare a mischio con la tela cinquececentesca che rappresenta “ Il ritrovamento della Croce” del pittore lombardo Giulio Musca.
Lato sinistro
Nella prima nicchia di sinistra una pregevole tela ancora di Antonio Manno “La Sacra famiglia e Santa Rosalia “ (1774) e ai piedi della nicchia il Gonfalone della confraternita dei “Cassari”.
Appare di notevole interesse la nicchia seguente, dove troviamo un crocifisso ligneo dei XVIII secolo assai efficace e accanto, la statua lignea della “Vergine Addolorata” di Girolamo Bagnasco; ai piedi il simulacro del Cristo morto che, insieme all’Addolorata vengono portati in processione dall’antica confraternita dei Cassari il Venerdì Santo.
Nella nicchia che segue possiamo ammirare un’altra opera di Antonio Manno “La Madonna di Monserrato” con i santi Ninfa, Antonio Abate, Nicola di Bari e Sebastiano sempre del 1774.
Più avanti si trova l’ingresso laterale alla chiesa sormontato da balconcino cantoria e appresso un monumento sepolcrale in marmi mischi.
Proseguendo, nell’emiciclo sinistro della tribuna, troviamo sul piccolo altare in marmo, un dipinto su tavola del 1584, molto “toccante”, che raffigura il “Martirio di Santa Caterina” attribuito al cremonese Giovanni Paolo Fonduli.
A seguire, sempre nella tribuna, sull’altare della seconda cappelletta è collocata una pala che rappresenta “Il compianto sul Cristo morto” significativa opera del XVIII secolo.
Infine sull’altare maggiore, fra decori in stucco (i pochi superstiti della ricca decorazione che ornava l’intera tribuna), è collocata una splendida pala di Pietro Albina (figlio del più noto Giuseppe detto il “Sozzo”) che raffigura “L’Immacolata Concezione“ del 1623, sormontata da un tondo con la colomba, simbolo dello Spirito Santo, sorretto da putti. Ai lati dell’altare due plastici serafini in stucco.
Parrocchia di Maria La Nova
90133 P.za S. Giacomo La MarinaUbicata in piazza San Giacomo la Marina, nell’antica contrada della “Tavola Tonda al Castellamare” (così chiamata per la presenza, un tempo, di numerosi fondaci e locande), tra il vecchio mercato della Vucciria e l’antico porto della Cala, la Chiesa di Santa Maria La Nova nacque dalla trasformazione di un oratorio annesso ad un’ospedale per la cura dei pellegrini eretto nel 1339 poi diventato Casa di Disciplina.
Nella stessa piazza, fino al 1860, quando se ne decretò la demolizione a seguito dei danneggiamenti causati dalle cannoniere borboniche durante i moti palermitani, esisteva l’antica chiesa di San Giacomo la Marina, fondata in epoca normanna, probabilmente dalla trasformazione di una moschea araba, anche se questa tesi non è suffragata da fonti documentarie certe, e quei pochi indizi di cui siamo in possesso dovrebbero essere verificati e approfonditi.
La nuova edificazione (da qui la denominazione di “Nova”) fu decisa dalla Confraternita di Santa Maria la Nova attorno al 1520 (pare a seguito di un evento ritenuto miracoloso), anche se la costruzione, nel cui cantiere lavorarono i “maestri fabbricatori” Giuseppe Spatafora e Giuseppe Giacalone, si protrasse per diversi decenni (fu compiuta nelle sue strutture principali almeno, nel 1582).
Nel 1585 vi fu istituita la Deputazione per la Redenzione dei Cattivi (dal latino captivi, cioè prigionieri), che aveva come compito istituzionale la raccolta delle elemosine per il riscatto degli schiavi cristiani fatti prigionieri dai turchi.
Il sacro edificio, durante l’ultimo conflitto mondiale, come tanti altri monumenti della città, veniva danneggiato in una incursione aerea nemica avvenuta nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo 1943. Gli effetti della deflagrazione di un ordigno caduto nelle sue vicinanze causarono il crollo del tetto del tiburio, e alcuni danni, per fortuna di poca entità, all’interno e agli infissi.
La chiesa di Santa Maria la Nova detiene il titolo parrocchiale e ha sempre svolto un ruolo di rilievo, sia nelle vicende religiose che in quelle economiche-sociali del quartiere della “Loggia” che fino alla metà del Novecento fu il centro del cuore economico della città.
Per quanto riguarda la configurazione esterna, questo edificio religioso rappresenta un mirabile esempio di architettura della prima metà del sec. XVI, testimonianza emblematica dell’architettura cinquecentesca a Palermo, ancora incentrata sull’evidente adesione a schemi di gusto Gotico-Catalano, a lungo presenti nell’architettura palermitana.
Di notevole importanza è l’elegante portico con loggiato il “Tocco”, sempre presente nelle chiese dei quartieri mercantili, che ingentilisce la facciata principale e precede l’ingresso alla chiesa.
Rinserrato fra due piloni angolari caratterizzati da aperture cieche che creano un plastico gioco di sporgenze, presenta tre arcate a mezzo sesto con ghiere a rincasso sorrette da due colonne in marmo con capitelli corinzi finemente lavorati.
La copertura del portico è costituita da volte a crociera costolonate con chiavi pendule, elementi riconoscibili della tradizione Gotico-Catalano: il loggiato è chiuso da una cancellata in ferro battuto.
L’osservatore attento non potrà fare a meno di notare che la facciata, nella sua parte superiore, si differenzia notevolmente dalla parte inferiore sia nello stile che nella muratura. Questa situazione deriva dagli interventi, piuttosto significativi, che interessarono l’edificio religioso nella prima metà dell’ottocento, dove è stato interamente realizzato in stile neogotico l’ordine superiore della facciata. Questo secondo ordine scandito da leggere paraste e chiuso da una cornicione con eleganti figurazioni scultoree a motivi “conchiliformi”, racchiude un oratorio della fine del XVI secolo di cui, sul lato sinistro, rimane una finestra dell’epoca; il risultato è tutto sommato, gradevole.
Si accede alla chiesa da un piccolo portale architravato sormontato da un medaglione in stucco dove è rappresentata la stella a otto punte simbolo della “Vergine”.
Nella parete di controfacciata, in una nicchia sopra il portale si trova una statua di Sant’Alessio protettore dei mendicanti.
L’architettura interna, di ordine corinzio, risulta molto pacata nel suo apparato ordinale di lesene che legano in modo sintatticamente corretto le pareti delle navate laterali con le volte. L’aula basilicale a triplice navata senza transetto di scuola gaginesca è caratterizzata da archi a pieno sesto che poggiano su colonne monolite con eleganti capitelli corinzi dove, una modesta illuminazione naturale che penetra appena dalle alte finestre laterali, crea suggestioni particolari.
Presenta pregevoli addobbi di stucchi settecenteschi, gustosamente distribuiti attribuiti a Procopio Serpotta. La tribuna ottagona con cupola, progettata dal piemontese Giorgio Di Faccio, di impianto centrico, è di chiaro stile rinascimentale.
Le navate laterali sono fiancheggiate da “rientranze” ricavate dallo spessore dei muri su entrambi i lati (solo una, la seconda di destra, è una cappella profonda, intitolata a Santa Maria la Nova) dove, anche se purtroppo molte sono state trafugate, si possono ammirare ancora opere d’arte di notevole interesse e valore artistico .
Il pavimento in marmo della navata centrale con stelle ad otto punte, che rimanda simbolicamente alla Vergine, è opera novecentesca realizzata su disegno di Francesco Paolo Palazzotto.
Lato destro
La prima nicchia a destra dell’ingresso custodisce una pregevole tela settecentesca di Carmelo Salpietra che raffigura “l’Angelo custode”.
Degna di nota la cappella che segue intitolata a Santa Maria la Nova, come dicevo l’unica cappella vera e propria. Sulla volta troviamo pregevoli affreschi che raffigurano la Vergine con i quattro Evangelisti.
Alle pareti tre elaborati monumenti funebri d’ispirazione manierista appartenenti alla nobile famiglia Giancardo, che un tempo deteneva il patrocinio della cappella, e sull’altare un dipinto settecentesco di notevole interesse che raffigura “La Madonna con Gesù e Santi” di Antonio Manno, allievo del più celebre pittore Vito D’Anna.
Nella cappella, entrando a destra, è custodito un dipinto su ardesia del tardo cinquecento che raffigura Cristo e la Vergine.
Nella nicchia successiva si trova un magnifico dipinto del 1774 ancora di Antonio Manno intitolato “Il Transito della Vergine”.
Successivamente troviamo l’ingresso alla sacrestia sormontato da un elegante balconcino di gusto rococò in funzione di cantoria.
Nell’ultima nicchia della navata si trova un monumento funebre in marmo.
Proseguendo arriviamo alla prima cappelletta dell’emiciclo destro della tribuna dove è collocato un dipinto che raffigura la Madonna del Lume del pittore Luigi Lo Jacono del 1883 con ai piedi un fonte battesimale.
Andando avanti troviamo un piccolo altare a mischio con la tela cinquececentesca che rappresenta “ Il ritrovamento della Croce” del pittore lombardo Giulio Musca.
Lato sinistro
Nella prima nicchia di sinistra una pregevole tela ancora di Antonio Manno “La Sacra famiglia e Santa Rosalia “ (1774) e ai piedi della nicchia il Gonfalone della confraternita dei “Cassari”.
Appare di notevole interesse la nicchia seguente, dove troviamo un crocifisso ligneo dei XVIII secolo assai efficace e accanto, la statua lignea della “Vergine Addolorata” di Girolamo Bagnasco; ai piedi il simulacro del Cristo morto che, insieme all’Addolorata vengono portati in processione dall’antica confraternita dei Cassari il Venerdì Santo.
Nella nicchia che segue possiamo ammirare un’altra opera di Antonio Manno “La Madonna di Monserrato” con i santi Ninfa, Antonio Abate, Nicola di Bari e Sebastiano sempre del 1774.
Più avanti si trova l’ingresso laterale alla chiesa sormontato da balconcino cantoria e appresso un monumento sepolcrale in marmi mischi.
Proseguendo, nell’emiciclo sinistro della tribuna, troviamo sul piccolo altare in marmo, un dipinto su tavola del 1584, molto “toccante”, che raffigura il “Martirio di Santa Caterina” attribuito al cremonese Giovanni Paolo Fonduli.
A seguire, sempre nella tribuna, sull’altare della seconda cappelletta è collocata una pala che rappresenta “Il compianto sul Cristo morto” significativa opera del XVIII secolo.
Infine sull’altare maggiore, fra decori in stucco (i pochi superstiti della ricca decorazione che ornava l’intera tribuna), è collocata una splendida pala di Pietro Albina (figlio del più noto Giuseppe detto il “Sozzo”) che raffigura “L’Immacolata Concezione“ del 1623, sormontata da un tondo con la colomba, simbolo dello Spirito Santo, sorretto da putti. Ai lati dell’altare due plastici serafini in stucco.
Fu costruita nel XV secolo per volere della comunità di mercanti catalani stabilitisi a Palermo intorno al XIII secolo. Il complesso è composto, oltre che dalla chiesa, anche da una serie di edifici, i quali hanno subito diverse trasformazioni, durante i secoli. Il complesso è di proprietà dello Stato spagnolo ed è diventata la sede del centro di cultura spagnola. Sulla strada si affaccia solo il fronte d’ingresso, costruito nel tardo ‘500 secondo lo stile plateresco, importato dalla Spagna.
Si tratta di un’articolata facciata, intelaiata da colonne e trabeazioni, disposta su tre ordini; negli ultimi sono alcune interessanti decorazioni: nel secondo ordine grandi arcate racchiudono stemmi e fregi; nel terzo, ghirlande a motivi floreali incorniciano busti di re aragonesi. Un passaggio scoperto immette alla chiesa, costruita nelle sue forme attuali, nel 1630 e lasciata incompleta. L’edificio ha pianta a croce greca su base quadrata; quattro pilastri dovevano sostenere la cupola mai costruita; una trabeazione continua corre sotto le volte, unificando lo spazio, suddiviso lateralmente da archi centrici; nei pennacchi si scorgono affreschi seicenteschi, mentre il paramento murario è intonacato con particolari architettonici in pietra.
Per le strutture interne sono state usate colonne in marmo provenienti da Barcellona. La chiesa possedeva alcuni buoni arredi e tele del XVII secolo, oggi al Museo Diocesano.
Chiesa di S. Eulalia dei Catalani
Fu costruita nel XV secolo per volere della comunità di mercanti catalani stabilitisi a Palermo intorno al XIII secolo. Il complesso è composto, oltre che dalla chiesa, anche da una serie di edifici, i quali hanno subito diverse trasformazioni, durante i secoli. Il complesso è di proprietà dello Stato spagnolo ed è diventata la sede del centro di cultura spagnola. Sulla strada si affaccia solo il fronte d’ingresso, costruito nel tardo ‘500 secondo lo stile plateresco, importato dalla Spagna.
Si tratta di un’articolata facciata, intelaiata da colonne e trabeazioni, disposta su tre ordini; negli ultimi sono alcune interessanti decorazioni: nel secondo ordine grandi arcate racchiudono stemmi e fregi; nel terzo, ghirlande a motivi floreali incorniciano busti di re aragonesi. Un passaggio scoperto immette alla chiesa, costruita nelle sue forme attuali, nel 1630 e lasciata incompleta. L’edificio ha pianta a croce greca su base quadrata; quattro pilastri dovevano sostenere la cupola mai costruita; una trabeazione continua corre sotto le volte, unificando lo spazio, suddiviso lateralmente da archi centrici; nei pennacchi si scorgono affreschi seicenteschi, mentre il paramento murario è intonacato con particolari architettonici in pietra.
Per le strutture interne sono state usate colonne in marmo provenienti da Barcellona. La chiesa possedeva alcuni buoni arredi e tele del XVII secolo, oggi al Museo Diocesano.
Le origini del Genio di Palermo sono del tutto ignote, come il suo significato, tuttavia è una delle più antiche e complesse figure mitologiche della tradizione, espressione di una spiritualità popolare antica le cui origini risalgono all’epoca pre-romana.
Questo Nume, (la cui radice indica l’atto del generare: in greco ghenos= nascita e in latino genius=generatore di vita) nella credenza popolare doveva essere una figura ultraterrena, un ente supremo col ruolo di protettore del luogo e delle famiglie: un Genius loci. A tale spirito divino bisognava mostrare assoluta devozione e riverenza, e offrire tributi appropriati. Una figura piuttosto antica conosciuta alle popolazioni mediterranee, ma anche a quelle Orientali, comprese l’India ed il Giappone.
Il mito, il culto e la tradizione antichissima di uno spirito della natura che accompagna e protegge l’uomo dalla nascita fino alla morte è stato un tema abbastanza diffuso nel passato. Una specie di dio minore, quasi personale, perfino, partecipe delle gioie e dei dolori degli individui, insomma.
Così concepito, il Genio con sfumature espressive e caratteristiche simili fu rappresentato in moltissimi modi nel corso della storia millenaria dell’uomo e si è protratto nello spazio e nel tempo fino a raggiungere la Sicilia.
Benché esistano testimonianze più antiche in Sicilia, il Genio compare a Palermo a partire dal XIV secolo, 1483, quando per volontà dei mercanti amalfitani, pisani, genovesi e catalani residenti a Palermo, venne fatta costruire una statua al fine di adornare il borgo del Garraffo, nel cuore del centro cittadino, come omaggio alla città: il Genio del Garraffo, o “Palermu u granni”, com’è conosciuto dal popolo palermitano, in contrapposizione a “Palermu u nicu” (il piccolo) all’interno del Palazzo di Città o delle Aquile.
Dopo questa prima rappresentazione, il mito-culto del Genio entra nel tessuto popolare cittadino di Palermo con sempre più assiduità nel ‘700 ed ‘800 quando lo troviamo raffigurato ora come statua, ora come fontana, ora in pittura e mosaico, come nella Cappella Palatina all’interno del Palazzo Reale.
La fontana originaria del “Garraffo” era posta là dove si trova adesso, nella parete laterale destra della piazzetta. Al di sopra stava la nicchia dove sera collocato il genio di Palermo e aveva cinque cannoli di bronzo da cui sgorgava abbondante acqua purissima; in basso, attraverso un grosso cannone, l’acqua si riversava dentro un abbeveratoio.
Nel 1697, forse a causa dell’umidità che danneggiava la parete dei bottegai limitrofi, la vasca venne abolita e fu costruita una nuova fontana al centro della piazza, opera di Gioacchino Vitagliano su progetto dell’Architetto Paolo Amato. La parete del Genio venne arricchita con un basamento in marmo di billiemi con al centro un’aquila reale e gli stemmi dei quattro quartieri della città: La “Serpe Verde” per l’Albergheria, “Ercole” o “Sansone” per il Capo, lo “Scudo Imperiale” della Loggia e la “Rosa” per la Kalsa . Ai lati del genio, due nicchie più piccole ospitavano due sante vergini protettrici della città.
Così rimase fino al primo dopoguerra, quando mani rimaste ignote trafugarono l’aquila, gli stemmi e le due statue delle sante lasciando il povero Genio nudo e crudo, con la sua serpe dalla coda rotta.
Non si conosce da dove origina l‘immagine del Genio, tuttavia le diverse raffigurazioni presentano caratteristiche piuttosto simili: un uomo dal giovane corpo muscoloso su un volto da anziano. Dal capo scendono lunghi capelli ed ha una lunga barba, spesso divisa in due ciocche distinte. In testa ha sempre la corona, come un re e come tale siede maestoso su di un’altura fatta di rocce. A volte è ricoperto solo da un mantello, mentre in altre versioni indossa un’armatura romana. In una mano a volte tiene uno scettro, ma sempre tra le sue mani è presente un serpente col muso rivolto verso il suo petto come a volerlo mordere o succhiare. In alcune rappresentazioni è sormontato da un’aquila reale, con un cane posto ai suoi piedi.
Sul significato simbolico degli elementi costitutivi delle rappresentazioni del genio di Palermo molto si è supposto e tuttavia i risultati sembrano piuttosto incerti se non arbitrari talvolta, per cui è meglio tralasciare. Una cosa è certa: a un certo punto della storia di Palermo, il Senato cittadino ha assunto l’emblema a simbolo della città e lo testimonia la statua posta all’interno del Palazzo Pretorio (Palermu u nicu) dove ai suoi piedi si legge la scritta: “Panormus conca aurea suos devorat alienus nutrit” (Palermo conca d’oro divora i suoi e nutre gli stranieri), espressione che con una punta di rammarico sembra indicare che la pianura in cui sorge Palermo (la Conca d’Oro) così ricca di risorse piuttosto che beneficiare i propri figli è stata sfruttata da genti straniere.
Genio del Garraffo
Le origini del Genio di Palermo sono del tutto ignote, come il suo significato, tuttavia è una delle più antiche e complesse figure mitologiche della tradizione, espressione di una spiritualità popolare antica le cui origini risalgono all’epoca pre-romana.
Questo Nume, (la cui radice indica l’atto del generare: in greco ghenos= nascita e in latino genius=generatore di vita) nella credenza popolare doveva essere una figura ultraterrena, un ente supremo col ruolo di protettore del luogo e delle famiglie: un Genius loci. A tale spirito divino bisognava mostrare assoluta devozione e riverenza, e offrire tributi appropriati. Una figura piuttosto antica conosciuta alle popolazioni mediterranee, ma anche a quelle Orientali, comprese l’India ed il Giappone.
Il mito, il culto e la tradizione antichissima di uno spirito della natura che accompagna e protegge l’uomo dalla nascita fino alla morte è stato un tema abbastanza diffuso nel passato. Una specie di dio minore, quasi personale, perfino, partecipe delle gioie e dei dolori degli individui, insomma.
Così concepito, il Genio con sfumature espressive e caratteristiche simili fu rappresentato in moltissimi modi nel corso della storia millenaria dell’uomo e si è protratto nello spazio e nel tempo fino a raggiungere la Sicilia.
Benché esistano testimonianze più antiche in Sicilia, il Genio compare a Palermo a partire dal XIV secolo, 1483, quando per volontà dei mercanti amalfitani, pisani, genovesi e catalani residenti a Palermo, venne fatta costruire una statua al fine di adornare il borgo del Garraffo, nel cuore del centro cittadino, come omaggio alla città: il Genio del Garraffo, o “Palermu u granni”, com’è conosciuto dal popolo palermitano, in contrapposizione a “Palermu u nicu” (il piccolo) all’interno del Palazzo di Città o delle Aquile.
Dopo questa prima rappresentazione, il mito-culto del Genio entra nel tessuto popolare cittadino di Palermo con sempre più assiduità nel ‘700 ed ‘800 quando lo troviamo raffigurato ora come statua, ora come fontana, ora in pittura e mosaico, come nella Cappella Palatina all’interno del Palazzo Reale.
La fontana originaria del “Garraffo” era posta là dove si trova adesso, nella parete laterale destra della piazzetta. Al di sopra stava la nicchia dove sera collocato il genio di Palermo e aveva cinque cannoli di bronzo da cui sgorgava abbondante acqua purissima; in basso, attraverso un grosso cannone, l’acqua si riversava dentro un abbeveratoio.
Nel 1697, forse a causa dell’umidità che danneggiava la parete dei bottegai limitrofi, la vasca venne abolita e fu costruita una nuova fontana al centro della piazza, opera di Gioacchino Vitagliano su progetto dell’Architetto Paolo Amato. La parete del Genio venne arricchita con un basamento in marmo di billiemi con al centro un’aquila reale e gli stemmi dei quattro quartieri della città: La “Serpe Verde” per l’Albergheria, “Ercole” o “Sansone” per il Capo, lo “Scudo Imperiale” della Loggia e la “Rosa” per la Kalsa . Ai lati del genio, due nicchie più piccole ospitavano due sante vergini protettrici della città.
Così rimase fino al primo dopoguerra, quando mani rimaste ignote trafugarono l’aquila, gli stemmi e le due statue delle sante lasciando il povero Genio nudo e crudo, con la sua serpe dalla coda rotta.
Non si conosce da dove origina l‘immagine del Genio, tuttavia le diverse raffigurazioni presentano caratteristiche piuttosto simili: un uomo dal giovane corpo muscoloso su un volto da anziano. Dal capo scendono lunghi capelli ed ha una lunga barba, spesso divisa in due ciocche distinte. In testa ha sempre la corona, come un re e come tale siede maestoso su di un’altura fatta di rocce. A volte è ricoperto solo da un mantello, mentre in altre versioni indossa un’armatura romana. In una mano a volte tiene uno scettro, ma sempre tra le sue mani è presente un serpente col muso rivolto verso il suo petto come a volerlo mordere o succhiare. In alcune rappresentazioni è sormontato da un’aquila reale, con un cane posto ai suoi piedi.
Sul significato simbolico degli elementi costitutivi delle rappresentazioni del genio di Palermo molto si è supposto e tuttavia i risultati sembrano piuttosto incerti se non arbitrari talvolta, per cui è meglio tralasciare. Una cosa è certa: a un certo punto della storia di Palermo, il Senato cittadino ha assunto l’emblema a simbolo della città e lo testimonia la statua posta all’interno del Palazzo Pretorio (Palermu u nicu) dove ai suoi piedi si legge la scritta: “Panormus conca aurea suos devorat alienus nutrit” (Palermo conca d’oro divora i suoi e nutre gli stranieri), espressione che con una punta di rammarico sembra indicare che la pianura in cui sorge Palermo (la Conca d’Oro) così ricca di risorse piuttosto che beneficiare i propri figli è stata sfruttata da genti straniere.
La Fontana del Garraffello, scolpita da Vincenzo Gagini nel 1591, è situata nell'omonima piazza, nel cuore del Mercato della Vucciria. Il suo nome deriva dalla parola araba gharraf, che significa "abbondante d'acqua".
Secondo una credenza popolare l'acqua che sgorgava dalla Fontana era miracolosa, tanto che moltissimi cittadini, anche residenti in altre zone della città, si fornivano da essa, facendo scorta addirittura a scopo curativo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale la Fontana si salvò dai bombardamenti, a differenza degli edifici circostanti che subirono danni in alcuni casi irreparabili.
Fountain Garraffello
22 Via GarraffelloLa Fontana del Garraffello, scolpita da Vincenzo Gagini nel 1591, è situata nell'omonima piazza, nel cuore del Mercato della Vucciria. Il suo nome deriva dalla parola araba gharraf, che significa "abbondante d'acqua".
Secondo una credenza popolare l'acqua che sgorgava dalla Fontana era miracolosa, tanto che moltissimi cittadini, anche residenti in altre zone della città, si fornivano da essa, facendo scorta addirittura a scopo curativo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale la Fontana si salvò dai bombardamenti, a differenza degli edifici circostanti che subirono danni in alcuni casi irreparabili.
L'opera venne scolpita dallo scultore Gioacchino Vitagliano nel 1698 su progetto di Paolo Amato.
La fontana del Garraffo fu realizzata, in stile barocco, nel 1698, e fu posta nel centro della piazza del Mercato della Vucciria, a Palermo. Il suo nome significa "abbondante d'acqua" e deriva dall'arabo gharraf.
La struttura marmorea è composta da una vasca contenente un'elevazione piramidale culminante con la figura di una dea dell'abbondanza che sormonta un'aquila in lotta contro un'idra.
Lungo i fianchi della pila centrale sono adagiati i corpi di delfini orientati nelle quattro direzioni, i quali sostengono con il capo e sospendono per la coda altrettante vasche a forma di conchiglia. Il gioco d'acqua prende avvio dalle bocche dell'idra, elemento che si riversa nel primo ordine di conche e defluisce nella teoria sottostante. Il ciclo si conclude attraverso le bocche dei quattro tursiopi alimentando la vasca il cui perimetro esterno ha la forma di un quadrato, con lobi mediani in corrispondenza dei getti provenienti dalle sculture, e angoli smussati. L'installazione poggia su un basamento elevato su tre gradini centrato su una piattaforma marmorea mistilinea.
Inizialmente il fonte monumentale era posto di fronte al Genio del Garraffo alla Vucciria, nell’omonima piazza. Nel 1862 fu spostata presso piazza Marina, dove è tutt’ora visbile.
Fontana del Garraffo
100 Via Vittorio EmanueleL'opera venne scolpita dallo scultore Gioacchino Vitagliano nel 1698 su progetto di Paolo Amato.
La fontana del Garraffo fu realizzata, in stile barocco, nel 1698, e fu posta nel centro della piazza del Mercato della Vucciria, a Palermo. Il suo nome significa "abbondante d'acqua" e deriva dall'arabo gharraf.
La struttura marmorea è composta da una vasca contenente un'elevazione piramidale culminante con la figura di una dea dell'abbondanza che sormonta un'aquila in lotta contro un'idra.
Lungo i fianchi della pila centrale sono adagiati i corpi di delfini orientati nelle quattro direzioni, i quali sostengono con il capo e sospendono per la coda altrettante vasche a forma di conchiglia. Il gioco d'acqua prende avvio dalle bocche dell'idra, elemento che si riversa nel primo ordine di conche e defluisce nella teoria sottostante. Il ciclo si conclude attraverso le bocche dei quattro tursiopi alimentando la vasca il cui perimetro esterno ha la forma di un quadrato, con lobi mediani in corrispondenza dei getti provenienti dalle sculture, e angoli smussati. L'installazione poggia su un basamento elevato su tre gradini centrato su una piattaforma marmorea mistilinea.
Inizialmente il fonte monumentale era posto di fronte al Genio del Garraffo alla Vucciria, nell’omonima piazza. Nel 1862 fu spostata presso piazza Marina, dove è tutt’ora visbile.
Dedicata alla moglie, Donna Felice Orsini, del vicerè Marcantonio Colonna, la sua edificazione fu iniziata nel 1582, ma i lavori, subito dopo, furono interrotti e ripresi nel 1602 sotto la direzione di Mariano Smiriglio e furono portati a termine nel 1637 da Vincenzo Tedeschi.
Differenze stilistiche caratterizzano non solo i diversi ordini , ma soprattutto i due prospetti. Il fronte esterno, che si affaccia sul mare, ha un aspetto più solenne, è rivestito in marmi chiari senza soluzione di continuità e presenta una serie di colonne, nicchie, balaustre, volute, stemmi e, ai piedi dei piloni, due fontane che furono qui collocate nel 1642.
Il prospetto della porta, rivolta verso la città, è impostato secondo una partitura ancora classicheggiante che rivela l’influenza dell’architettura romana tardo-manieristica. Nel paramento in pietra, sottolineato da paraste, sono inserite classiche aperture ad edicola ed oculi ovoidali.
Porta Felice era l’unica porta cittadina che veniva chiusa ad un’ora tarda della notte; durante il XVIII secolo, infatti, era usanza dell’aristocrazia trascorrere le serate estive nella frescura della marina.
26 Recomendado por los habitantes de la zona
Porta Felice
Foro Italico Umberto IDedicata alla moglie, Donna Felice Orsini, del vicerè Marcantonio Colonna, la sua edificazione fu iniziata nel 1582, ma i lavori, subito dopo, furono interrotti e ripresi nel 1602 sotto la direzione di Mariano Smiriglio e furono portati a termine nel 1637 da Vincenzo Tedeschi.
Differenze stilistiche caratterizzano non solo i diversi ordini , ma soprattutto i due prospetti. Il fronte esterno, che si affaccia sul mare, ha un aspetto più solenne, è rivestito in marmi chiari senza soluzione di continuità e presenta una serie di colonne, nicchie, balaustre, volute, stemmi e, ai piedi dei piloni, due fontane che furono qui collocate nel 1642.
Il prospetto della porta, rivolta verso la città, è impostato secondo una partitura ancora classicheggiante che rivela l’influenza dell’architettura romana tardo-manieristica. Nel paramento in pietra, sottolineato da paraste, sono inserite classiche aperture ad edicola ed oculi ovoidali.
Porta Felice era l’unica porta cittadina che veniva chiusa ad un’ora tarda della notte; durante il XVIII secolo, infatti, era usanza dell’aristocrazia trascorrere le serate estive nella frescura della marina.
Vi si conserva e si può ammirare il famoso dipinto "Vucciria" opera di Renato Guttuso del 1974.
Costruito intorno al 1320 da Manfredi I appartenente ai Chiaramonte, che rappresentava una delle famiglie più rinomate, al punto da esercitare una grande influenza politica e militare su buona parte della Sicilia Occidentale, oggi è sede del Rettorato dell’Università di Palermo. Il Palazzo ha un impianto quadrato incentrato intorno ad un cortile porticato a due ordini: massiccio il primo, con archi ogivali sostenuti da tozze colonne, più aereo il secondo dove gli archi poggiano su esili colonne; distribuito su tre piani.
Tutti i vani prendono luce da bifore poste sui prospetti, tranne il salone settentrionale che presenta due serie di eleganti trifore sui due lati lunghi e si affaccia sulla corte interna. Le aperture sono impostate su esili colonnine, di cui alcune tortili, e concluse da archetti decorati da fasce bicrome o da ghiere a bastoni disposti a zig-zag; un’ampia cornice archiacuta a delicati motivi geometrici intrecciati racchiude le finestre. Nelle trifore, tre decorazioni circolari, inserite nella lunetta, formano un ulteriore motivo decorativo. Le finestre del secondo piano sono più semplici ed hanno minore cura del dettaglio.
Al primo piano si può ammirare la Sala Magna, sala di rappresentanza del Rettore, ornata da un prezioso soffitto ligneo dipinto con scene che rappresentano avventure cavalleresche nel 1377 e al secondo piano, la Sala delle Capriate, utilizzata per conferenze e importanti avvenimenti culturali.
Durante i secoli il Palazzo mutò diverse volte la sua destinazione d’uso: fu residenza dei Viceré spagnoli, ospitò gli Uffici della Dogana, fu sede del Tribunale della Santa Inquisizione con annesse Carceri della Penitenza, divenne rifugio per i poveri e vi furono collocati gli uffici giudiziari. Annessa allo Steri è la piccola Chiesa di S. Antonio Abate in stile gotico trecentesco.
Orari:
Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20 (1 marzo-31 ottobre)
Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 (1 novembre - 28 febbraio)
150 Recomendado por los habitantes de la zona
Palazzo Chiaramonte
60 Piazza MarinaVi si conserva e si può ammirare il famoso dipinto "Vucciria" opera di Renato Guttuso del 1974.
Costruito intorno al 1320 da Manfredi I appartenente ai Chiaramonte, che rappresentava una delle famiglie più rinomate, al punto da esercitare una grande influenza politica e militare su buona parte della Sicilia Occidentale, oggi è sede del Rettorato dell’Università di Palermo. Il Palazzo ha un impianto quadrato incentrato intorno ad un cortile porticato a due ordini: massiccio il primo, con archi ogivali sostenuti da tozze colonne, più aereo il secondo dove gli archi poggiano su esili colonne; distribuito su tre piani.
Tutti i vani prendono luce da bifore poste sui prospetti, tranne il salone settentrionale che presenta due serie di eleganti trifore sui due lati lunghi e si affaccia sulla corte interna. Le aperture sono impostate su esili colonnine, di cui alcune tortili, e concluse da archetti decorati da fasce bicrome o da ghiere a bastoni disposti a zig-zag; un’ampia cornice archiacuta a delicati motivi geometrici intrecciati racchiude le finestre. Nelle trifore, tre decorazioni circolari, inserite nella lunetta, formano un ulteriore motivo decorativo. Le finestre del secondo piano sono più semplici ed hanno minore cura del dettaglio.
Al primo piano si può ammirare la Sala Magna, sala di rappresentanza del Rettore, ornata da un prezioso soffitto ligneo dipinto con scene che rappresentano avventure cavalleresche nel 1377 e al secondo piano, la Sala delle Capriate, utilizzata per conferenze e importanti avvenimenti culturali.
Durante i secoli il Palazzo mutò diverse volte la sua destinazione d’uso: fu residenza dei Viceré spagnoli, ospitò gli Uffici della Dogana, fu sede del Tribunale della Santa Inquisizione con annesse Carceri della Penitenza, divenne rifugio per i poveri e vi furono collocati gli uffici giudiziari. Annessa allo Steri è la piccola Chiesa di S. Antonio Abate in stile gotico trecentesco.
Orari:
Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20 (1 marzo-31 ottobre)
Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 (1 novembre - 28 febbraio)
Oggi il quattrocentesco Palazzo Abatellis ospita la Galleria Regionale che è uno dei più prestigiosi musei italiani e al suo interno sono custodite preziose opere dal valore immenso. Il palazzo ospita capolavori che da soli valgono un viaggio a Palermo: nelle spaziose sale del museo vi sono esposte opere di artisti siciliani medioevali e dei secoli XVI, XVII e XVIII.
Alcune meritano un cenno particolare: il grande murale del Maestro del “Trionfo della Morte”, opera immensa che ispirò Pablo Picasso per uno dei suoi capolavori la “Guernica” (impossibile non notare la somiglianza tra il cavallo del dipinto del maestro spagnolo e quello del nostro affresco), il busto-ritratto marmoreo di Eleonora d’Aragona realizzato da Francesco Laurana, e infine la celeberrima “Annunziata” di Antonello da Messina, capolavoro universale, una delle opere pittoriche più conosciute al mondo.
Biglietto Palazzo Abatellis:
Intero € 8.00
Ridotto € 4,00
Biglietto cumulativo (validità 3 gg.)
- Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
- Museo di Palazzo Mirto
- Oratorio dei Bianchi
Intero € 10.00
Ridotto € 5,00
259 Recomendado por los habitantes de la zona
Palazzo Abatellis
4 Via AlloroOggi il quattrocentesco Palazzo Abatellis ospita la Galleria Regionale che è uno dei più prestigiosi musei italiani e al suo interno sono custodite preziose opere dal valore immenso. Il palazzo ospita capolavori che da soli valgono un viaggio a Palermo: nelle spaziose sale del museo vi sono esposte opere di artisti siciliani medioevali e dei secoli XVI, XVII e XVIII.
Alcune meritano un cenno particolare: il grande murale del Maestro del “Trionfo della Morte”, opera immensa che ispirò Pablo Picasso per uno dei suoi capolavori la “Guernica” (impossibile non notare la somiglianza tra il cavallo del dipinto del maestro spagnolo e quello del nostro affresco), il busto-ritratto marmoreo di Eleonora d’Aragona realizzato da Francesco Laurana, e infine la celeberrima “Annunziata” di Antonello da Messina, capolavoro universale, una delle opere pittoriche più conosciute al mondo.
Biglietto Palazzo Abatellis:
Intero € 8.00
Ridotto € 4,00
Biglietto cumulativo (validità 3 gg.)
- Galleria Regionale di Palazzo Abatellis
- Museo di Palazzo Mirto
- Oratorio dei Bianchi
Intero € 10.00
Ridotto € 5,00
Palazzo Mirto è stato per quattro secoli la dimora palermitana della antica e nobile famiglia dei Filangeri, il cui arrivo in Sicilia si fa risalire al periodo normanno. Il titolo di Mirto perviene al casato attraverso Giuseppe Filangeri e Spuches, nominato nel 1643 ""primo principe di Mirto"", dal nome di un feudo ricadente nel territorio di Messina.
L'edificio è il risultato di numerose trasformazioni che si sono succedute nei secoli.
Nel 1982, l'ultima erede della famiglia, la nobildonna Maria Concetta Lanza Filangeri, adempiendo alle volontà del fratello Stefano, donò il palazzo alla Regione Sicilia affinché fosse mantenuto nella sua integrità e aperto alla pubblica fruizione. Il palazzo e così strutturato: Al piano terreno le ex carceri, la grande e piccola cucina, le scuderie ove sono custoditi carrozze, calessi e finimenti del secolo XIX, costituenti la raccolta Martorana Genuardi dei Baroni di Molinazzo, ormai di proprietà dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali, i magazzini, gli ambienti destinati alla servitù, che con il terzo piano, sede dell’amministrazione della casa, completano la struttura del palazzo.
Il primo piano, o piano nobile, presenta una sequenza di ambienti sontuosamente arredati, che si susseguono uno dopo l’altro, intorno ad un cortile pensile con una splendida fontana barocca e culminanti nel Salone del Baldacchino e nel Salone degli Arazzi.
Il secondo piano, pur contenendo ambienti destinati ad un uso sociale, ma per una più ristretta cerchia di amici, era riservato alla vita privata della famiglia.
96 Recomendado por los habitantes de la zona
Museo Palazzo Mirto House
2 Via MerloPalazzo Mirto è stato per quattro secoli la dimora palermitana della antica e nobile famiglia dei Filangeri, il cui arrivo in Sicilia si fa risalire al periodo normanno. Il titolo di Mirto perviene al casato attraverso Giuseppe Filangeri e Spuches, nominato nel 1643 ""primo principe di Mirto"", dal nome di un feudo ricadente nel territorio di Messina.
L'edificio è il risultato di numerose trasformazioni che si sono succedute nei secoli.
Nel 1982, l'ultima erede della famiglia, la nobildonna Maria Concetta Lanza Filangeri, adempiendo alle volontà del fratello Stefano, donò il palazzo alla Regione Sicilia affinché fosse mantenuto nella sua integrità e aperto alla pubblica fruizione. Il palazzo e così strutturato: Al piano terreno le ex carceri, la grande e piccola cucina, le scuderie ove sono custoditi carrozze, calessi e finimenti del secolo XIX, costituenti la raccolta Martorana Genuardi dei Baroni di Molinazzo, ormai di proprietà dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali, i magazzini, gli ambienti destinati alla servitù, che con il terzo piano, sede dell’amministrazione della casa, completano la struttura del palazzo.
Il primo piano, o piano nobile, presenta una sequenza di ambienti sontuosamente arredati, che si susseguono uno dopo l’altro, intorno ad un cortile pensile con una splendida fontana barocca e culminanti nel Salone del Baldacchino e nel Salone degli Arazzi.
Il secondo piano, pur contenendo ambienti destinati ad un uso sociale, ma per una più ristretta cerchia di amici, era riservato alla vita privata della famiglia.
La chiesa fu edificata due volte in trent’anni in seguito alla distruzione della prima, ordinata da Federico II per vendicarsi della scomunica subita dal Papa. L’attuale edificio fu costruita tra il 1255 ed il 1277. la definizione della facciata avvenne all’inizio del XIV secolo con la costruzione del portale a triplice ghiera, il quale termina in alto con un timpano triangolare, ove è iscritta una trifora cieca, decorata da pitture.
Nel 1872, il prospetto fu interessato da un profondo restauro, eseguito sotto la direzione di Giuseppe Patricolo, il quale sostituì il rosone precedente, che era andato perduto durante le trasformazioni apportate alla chiesa, basandosi sul disegno del coevo rosone della chiesa di S. Agostino.
L’interno è ampio a tre navate con profonde cappelle, tra le quali, di notevole rilievo , da menzionare sono: la Cappella Mastrantonio, realizzata da Francesco Laurana nel 1462, importante opera del primo rinascimento e la Cappella dell’Immacolata, a destra del presbiterio, decorata nel 1624 a spese del Senato cittadino, dove è possibile apprezzare la meravigliosa decorazione a marmi mischi che copre senza soluzione di continuità le pareti su cui si affacciano otto statue di Santi.
Tra le opere d’arte presenti al suo interno, si possono ammirare quelle realizzate da Domenico e Antonello Gagini, Pietro Novelli, Giacomo Serpotta etc.
65 Recomendado por los habitantes de la zona
Basilica of St. Francis of Assisi
Piazza San FrancescoLa chiesa fu edificata due volte in trent’anni in seguito alla distruzione della prima, ordinata da Federico II per vendicarsi della scomunica subita dal Papa. L’attuale edificio fu costruita tra il 1255 ed il 1277. la definizione della facciata avvenne all’inizio del XIV secolo con la costruzione del portale a triplice ghiera, il quale termina in alto con un timpano triangolare, ove è iscritta una trifora cieca, decorata da pitture.
Nel 1872, il prospetto fu interessato da un profondo restauro, eseguito sotto la direzione di Giuseppe Patricolo, il quale sostituì il rosone precedente, che era andato perduto durante le trasformazioni apportate alla chiesa, basandosi sul disegno del coevo rosone della chiesa di S. Agostino.
L’interno è ampio a tre navate con profonde cappelle, tra le quali, di notevole rilievo , da menzionare sono: la Cappella Mastrantonio, realizzata da Francesco Laurana nel 1462, importante opera del primo rinascimento e la Cappella dell’Immacolata, a destra del presbiterio, decorata nel 1624 a spese del Senato cittadino, dove è possibile apprezzare la meravigliosa decorazione a marmi mischi che copre senza soluzione di continuità le pareti su cui si affacciano otto statue di Santi.
Tra le opere d’arte presenti al suo interno, si possono ammirare quelle realizzate da Domenico e Antonello Gagini, Pietro Novelli, Giacomo Serpotta etc.

Cosa Vedere
Itinerari Turistici
Dove Dormire
Dove Mangiare
C.I.T.
Turismo Accessibile
Home
>
Cosa Vedere
>
Chiese ed Oratori
>
Oratorio di San Lorenzo
Oratorio di San Lorenzo

fino al 1969 vi si conservava una natività dipinta dal Caravaggio nel 1609.
Costruito nella seconda metà del XVI secolo dalla Compagnia di San Francesco in San Lorenzo, istituita nel 1564. Vi si accede da un cortiletto scoperto con fontana, su cui si affacciano i locali della canonica. L’oratorio è ad aula con cappellone rettangolare e di notevole pregio è il ricchissimo repertorio scultoreo a stucco che orna le pareti eseguito tra il 1699 e il 1706 da Giacomo Serpotta, dove vengono rappresentate scene di vita di San Francesco posti nei quadroni del lato destro dell’edificio e, sulla parete opposta sono quelli che illustrano episodi della vita di San Lorenzo; il tutto ulteriormente abbellito da una sequenza di puttini e fregi, i quali introducono una nota gaia e vivace.
I tre rilievi sulla parete d’ingresso sono dedicati alla preghiera ed al martirio di S. Lorenzo e alle stimmate di S. Francesco. Otto figure allegoriche di Virtù, di grandi dimensioni sono disposte lungo le pareti longitudinali; altre due, Carità e Ospitalità, sono poste ai lati dell’arco che introduce il cappellone, su cui poggia la figura di “S. Francesco che riceve il cordiglio dell’Ordine”. L’altare, con mensa in marmo e bronzi dorati, è stato eseguito su disegni di Giacomo Amato; sulla parete di fondo, affiancata da paraste e conclusa da timpano curvilineo, era collocata la “Natività” eseguita da Caravaggio nel 1609 e trafugata nel 1969. La chiesa conserva pregevoli sedili parietali in ebano intarsiati in madreperla ed altri arredi.
Fino al 1969,anno in cui fu rubata, l'altare maggiore ospitava una pregevole tela eseguita dal Caravaggio, "La Natività", del 1609. Recentemente l'opera torna al suo posto con una fedelissima riproduzione, realizzata in un unico esemplare con tecniche ad altissima tecnologia in grado di rendere alla perfezione ogni minimo dettaglio dell'originale.
Orari:
Tutti i giorni 10:00 – 18:00.
24 Dicembre 10:00 – 14:00.
31 Dicembre 10:00 – 14:00.
01 Gennaio 14:00 – 18:00.
Chiusi il 25 Dicembre e il 15 Agosto.
33 Recomendado por los habitantes de la zona
Oratorio di San Lorenzo
5 Via Immacolatella
Cosa Vedere
Itinerari Turistici
Dove Dormire
Dove Mangiare
C.I.T.
Turismo Accessibile
Home
>
Cosa Vedere
>
Chiese ed Oratori
>
Oratorio di San Lorenzo
Oratorio di San Lorenzo

fino al 1969 vi si conservava una natività dipinta dal Caravaggio nel 1609.
Costruito nella seconda metà del XVI secolo dalla Compagnia di San Francesco in San Lorenzo, istituita nel 1564. Vi si accede da un cortiletto scoperto con fontana, su cui si affacciano i locali della canonica. L’oratorio è ad aula con cappellone rettangolare e di notevole pregio è il ricchissimo repertorio scultoreo a stucco che orna le pareti eseguito tra il 1699 e il 1706 da Giacomo Serpotta, dove vengono rappresentate scene di vita di San Francesco posti nei quadroni del lato destro dell’edificio e, sulla parete opposta sono quelli che illustrano episodi della vita di San Lorenzo; il tutto ulteriormente abbellito da una sequenza di puttini e fregi, i quali introducono una nota gaia e vivace.
I tre rilievi sulla parete d’ingresso sono dedicati alla preghiera ed al martirio di S. Lorenzo e alle stimmate di S. Francesco. Otto figure allegoriche di Virtù, di grandi dimensioni sono disposte lungo le pareti longitudinali; altre due, Carità e Ospitalità, sono poste ai lati dell’arco che introduce il cappellone, su cui poggia la figura di “S. Francesco che riceve il cordiglio dell’Ordine”. L’altare, con mensa in marmo e bronzi dorati, è stato eseguito su disegni di Giacomo Amato; sulla parete di fondo, affiancata da paraste e conclusa da timpano curvilineo, era collocata la “Natività” eseguita da Caravaggio nel 1609 e trafugata nel 1969. La chiesa conserva pregevoli sedili parietali in ebano intarsiati in madreperla ed altri arredi.
Fino al 1969,anno in cui fu rubata, l'altare maggiore ospitava una pregevole tela eseguita dal Caravaggio, "La Natività", del 1609. Recentemente l'opera torna al suo posto con una fedelissima riproduzione, realizzata in un unico esemplare con tecniche ad altissima tecnologia in grado di rendere alla perfezione ogni minimo dettaglio dell'originale.
Orari:
Tutti i giorni 10:00 – 18:00.
24 Dicembre 10:00 – 14:00.
31 Dicembre 10:00 – 14:00.
01 Gennaio 14:00 – 18:00.
Chiusi il 25 Dicembre e il 15 Agosto.
Una chiesa dedicata allo stesso Santo esisteva nel XII secolo di fronte all’attuale; essa ospitò il primo nucleo di frati Domenicani, appena giunti a Palermo e fu poi inglobata nelle strutture trecentesche del monastero di S. Caterina. L’edificio attuale fu costruito tra il 1634 e il 1647 e fu affidato alla Confraternita dei Miseremini, la quale si occupava di celebrare messe in suffragio dei penitenti del Purgatorio.
Di notevole interesse è la facciata barocca eseguita da Carlo D’Aprile e Gaspare Guercio nel 1660, la quale è arricchita da colonne, cornici, volute e nicchie e da vari lavori d’intaglio, il tutto sormontato da un campanile centrale a tre luci. L’interno è a pianta basilicale a tre navate, transetto e cappellone rettangolare; ornata da rivestimenti parietali in marmo, decorazioni pittoriche e a stucco ed affreschi, tra i quali non si possono non menzionare quelli realizzati da Vito D’Anna, per la volta con “l’Apoteosi dei santi Matteo e Mattia” e “Le anime liberate dal Purgatorio” e, nella cupola “Trionfo della Vergine”, che ne fanno un tempio prettamente barocco.
Nel 1729 Giacomo Serpotta eseguì gli stucchi che ornano la chiesa; mentre gli stucchi dorati ed i medaglioni tra gli archi sono di Bartolomeo Sanseverino.
San Matteo al Cassaro
295 Via Vittorio EmanueleUna chiesa dedicata allo stesso Santo esisteva nel XII secolo di fronte all’attuale; essa ospitò il primo nucleo di frati Domenicani, appena giunti a Palermo e fu poi inglobata nelle strutture trecentesche del monastero di S. Caterina. L’edificio attuale fu costruito tra il 1634 e il 1647 e fu affidato alla Confraternita dei Miseremini, la quale si occupava di celebrare messe in suffragio dei penitenti del Purgatorio.
Di notevole interesse è la facciata barocca eseguita da Carlo D’Aprile e Gaspare Guercio nel 1660, la quale è arricchita da colonne, cornici, volute e nicchie e da vari lavori d’intaglio, il tutto sormontato da un campanile centrale a tre luci. L’interno è a pianta basilicale a tre navate, transetto e cappellone rettangolare; ornata da rivestimenti parietali in marmo, decorazioni pittoriche e a stucco ed affreschi, tra i quali non si possono non menzionare quelli realizzati da Vito D’Anna, per la volta con “l’Apoteosi dei santi Matteo e Mattia” e “Le anime liberate dal Purgatorio” e, nella cupola “Trionfo della Vergine”, che ne fanno un tempio prettamente barocco.
Nel 1729 Giacomo Serpotta eseguì gli stucchi che ornano la chiesa; mentre gli stucchi dorati ed i medaglioni tra gli archi sono di Bartolomeo Sanseverino.
Denominata, Vigliena, dal nome del vicerè spagnolo sotto cui terminò la sua prima sistemazione nel 1620, resa necessaria in seguito all’apertura di via Maqueda, nel 1600. L'incrocio che si venne a creare, tra via Maqueda e via Vittorio Emanuele, portò alla suddivisione della città in quattro parti detti “Mandamenti”.
Ognuno di essi prende il nome dall’edificio civile più importante di quella zona: Capo o Monte di Pietà, Albergheria o Palazzo Reale, Kalsa o Tribunali e Loggia o Castellammare. Varie definizioni sono state coniate per la costruzione barocca delle “quattro cantoniere”, tra queste: Teatro del Sole, perché in ogni stagione, almeno uno dei quattro cantoni è lambito dalla luce solare; oppure “ottagono”, per la sua forma.
La piazza si presenta perfettamente circolare ed i cantoni, realizzati in pietra da taglio con particolari in pietra di Billiemi sono curvilinei. La costruzione dei cantoni, iniziata nel 1608 su progetto di Giulio Lasso e proseguita sotto la guida di Mariano Smiriglio, fu portata a termine nel 1621. Ciascun cantone ha in sovrapposizione i tre ordini: dorico, ionico e composito. Nell’ordine inferiore sono le statue delle “Stagioni”, in quello medio le statue di quattro re spagnoli, le quali si presentavano originariamente in bronzo e sostituite con le attuali in marmo di Carrara nel 1661 ed, infine, nell’ordine superiore vi sono le statue delle sante protettrici di ogni mandamento (S. Oliva, S. Cristina, S. Agata e S. Ninfa).
Sui timpani dei balconi si possono ammirare degli angeli con palme e corone; sull’attico è stato collocato lo stemma reale spagnolo tra quello viceregio e pretorio. Nel 1856, per migliorare lo smaltimento delle acque piovane, il Senato decise l’abbassamento del livello stradale di via Maqueda e ad ogni cantone venne aggiunta una vasca sotto le fontane.
Tienda de viajes Quattrocanti Sicily
Piazza ViglienaDenominata, Vigliena, dal nome del vicerè spagnolo sotto cui terminò la sua prima sistemazione nel 1620, resa necessaria in seguito all’apertura di via Maqueda, nel 1600. L'incrocio che si venne a creare, tra via Maqueda e via Vittorio Emanuele, portò alla suddivisione della città in quattro parti detti “Mandamenti”.
Ognuno di essi prende il nome dall’edificio civile più importante di quella zona: Capo o Monte di Pietà, Albergheria o Palazzo Reale, Kalsa o Tribunali e Loggia o Castellammare. Varie definizioni sono state coniate per la costruzione barocca delle “quattro cantoniere”, tra queste: Teatro del Sole, perché in ogni stagione, almeno uno dei quattro cantoni è lambito dalla luce solare; oppure “ottagono”, per la sua forma.
La piazza si presenta perfettamente circolare ed i cantoni, realizzati in pietra da taglio con particolari in pietra di Billiemi sono curvilinei. La costruzione dei cantoni, iniziata nel 1608 su progetto di Giulio Lasso e proseguita sotto la guida di Mariano Smiriglio, fu portata a termine nel 1621. Ciascun cantone ha in sovrapposizione i tre ordini: dorico, ionico e composito. Nell’ordine inferiore sono le statue delle “Stagioni”, in quello medio le statue di quattro re spagnoli, le quali si presentavano originariamente in bronzo e sostituite con le attuali in marmo di Carrara nel 1661 ed, infine, nell’ordine superiore vi sono le statue delle sante protettrici di ogni mandamento (S. Oliva, S. Cristina, S. Agata e S. Ninfa).
Sui timpani dei balconi si possono ammirare degli angeli con palme e corone; sull’attico è stato collocato lo stemma reale spagnolo tra quello viceregio e pretorio. Nel 1856, per migliorare lo smaltimento delle acque piovane, il Senato decise l’abbassamento del livello stradale di via Maqueda e ad ogni cantone venne aggiunta una vasca sotto le fontane.
Costruita tra il 1612 e il 1645, su progetto del teatino Giacomo Besio. Danneggiata dai bombardamenti del 1943, la chiesa è stata restaurata e riaperta nel 1966. La facciata principale fu ultimata solo nel 1844 in stile neoclassico; nella nicchia sopra il portale è la statua del Santo titolare; sotto è posto lo stemma dei Falegnami che qui avevano la loro chiesetta intitolata a S. Elia.
L’interno è grandioso, ripartito in tre navate da altissime colonne monolitiche, ha profondo presbiterio con abside semicircolare; sugli arconi del transetto si innalza la slanciata cupola. Particolarmente fastosa è la decorazione interna: tutti i soffitti sono interamente affrescati; le pareti e le cappelle laterali sono rivestite in marmi mischi; gli altari presentano eleganti elaborazioni in pietre semipreziose; anche gli arredi lignei sono concepiti secondo un calibrato spirito decorativo barocco. Ai lati dell’ingresso sono due acquasantiere in marmo, rette da angeli in stucco, eseguite alla fine del ‘700 da Ignazio Marabitti e Filippo Siragusa.
La volta della navata centrale illustra con affreschi seicenteschi di Filippo Tancredi, episodi della “vita di S. Gaetano” tra stucchi dorati; nelle vele degli archi sono le “figure degli Apostoli”, iniziate nel 1798 da Giuseppe Velasquez e compiute da Vincenzo Manno. La cupola fu dipinta con il “Trionfo di S. Andrea d’Avellino” nel 1734 da Guglielmo Borremans.
Sotto la Chiesa di San Giuseppe dei Teatini è possibile visitare l’antica chiesa ipogea dedicata alla Madonna della Provvidenza dove si può ammirare un piccolo quadro che rappresenta la Madonna e Gesù incoronati risalente al 1610. Il quadro, secondo la tradizione, ha garantito molte grazie per diversi secoli. All’interno della chiesa vi è un pozzo, detto della sorgente miracolosa perché la tradizione vuole che le sue acque siano in grado di curare ogni male.
64 Recomendado por los habitantes de la zona
Church of Saint Joseph of the Theatine Fathers
SNC Via Vittorio EmanueleCostruita tra il 1612 e il 1645, su progetto del teatino Giacomo Besio. Danneggiata dai bombardamenti del 1943, la chiesa è stata restaurata e riaperta nel 1966. La facciata principale fu ultimata solo nel 1844 in stile neoclassico; nella nicchia sopra il portale è la statua del Santo titolare; sotto è posto lo stemma dei Falegnami che qui avevano la loro chiesetta intitolata a S. Elia.
L’interno è grandioso, ripartito in tre navate da altissime colonne monolitiche, ha profondo presbiterio con abside semicircolare; sugli arconi del transetto si innalza la slanciata cupola. Particolarmente fastosa è la decorazione interna: tutti i soffitti sono interamente affrescati; le pareti e le cappelle laterali sono rivestite in marmi mischi; gli altari presentano eleganti elaborazioni in pietre semipreziose; anche gli arredi lignei sono concepiti secondo un calibrato spirito decorativo barocco. Ai lati dell’ingresso sono due acquasantiere in marmo, rette da angeli in stucco, eseguite alla fine del ‘700 da Ignazio Marabitti e Filippo Siragusa.
La volta della navata centrale illustra con affreschi seicenteschi di Filippo Tancredi, episodi della “vita di S. Gaetano” tra stucchi dorati; nelle vele degli archi sono le “figure degli Apostoli”, iniziate nel 1798 da Giuseppe Velasquez e compiute da Vincenzo Manno. La cupola fu dipinta con il “Trionfo di S. Andrea d’Avellino” nel 1734 da Guglielmo Borremans.
Sotto la Chiesa di San Giuseppe dei Teatini è possibile visitare l’antica chiesa ipogea dedicata alla Madonna della Provvidenza dove si può ammirare un piccolo quadro che rappresenta la Madonna e Gesù incoronati risalente al 1610. Il quadro, secondo la tradizione, ha garantito molte grazie per diversi secoli. All’interno della chiesa vi è un pozzo, detto della sorgente miracolosa perché la tradizione vuole che le sue acque siano in grado di curare ogni male.
La chiesa, visitabile tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00, venne edificata per volontà della priora Suor Maria del Carretto nel 1566 e ultimata nel 1596, su un edificio pre-esistente. L'edificio ha subito notevoli danni a causa dei bombardamenti anglo-americani del 1943.
Dal luglio 2014 non accoglie più le monache domenicane ma è affidata alla curia palermitana. La proprietà è del FEC (Fondo Edifici Culto).
La chiesa veniva ricordata per la pompa con cui si realizzavano i sepolcri durante la settimana santa, quando veniva esposta la famosa "tila", opera di G. Patricolo.
Il monastero domenicano.
Era considerato uno dei monasteri primari di Palermo; le religiose provenienti da nobili famiglie professavano la regola di San Domenico. Il monastero sorse dopo il 1311 per volontà testamentaria di B. Mastrangelo. Nel 1532, a causa dell'accrescersi del numero delle religiose, venne acquistata dal monastero la chiesa di San Matteo per ingrandire l'edificio. Nel XVII secolo il monastero era diventato per ricchezza ed estensione, uno dei più importanti della città e occupava ormai un'intero isolato. Il monastero subì diversi danneggiamenti sia durante i moti del 1848 e del 1860, che durante i bombardamenti del 1943.
Le ultime religiose hanno lasciato il monastero nel 2014 e oggi è aperto al pubblico e gestito dalla curia. La proprietà è del FEC (Fondo Edifici Culto).
Dal 2018 ospita la mostra "Sacra et Pretiosa".
Al suo interno si trova la dolceria, dove vengono riprodotti i dolci di svariati monasteri di Palermo secondo le antiche ricette delle suore.
89 Recomendado por los habitantes de la zona
Iglesia de Santa Catalina de Alejandría
1 Piazza BelliniLa chiesa, visitabile tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00, venne edificata per volontà della priora Suor Maria del Carretto nel 1566 e ultimata nel 1596, su un edificio pre-esistente. L'edificio ha subito notevoli danni a causa dei bombardamenti anglo-americani del 1943.
Dal luglio 2014 non accoglie più le monache domenicane ma è affidata alla curia palermitana. La proprietà è del FEC (Fondo Edifici Culto).
La chiesa veniva ricordata per la pompa con cui si realizzavano i sepolcri durante la settimana santa, quando veniva esposta la famosa "tila", opera di G. Patricolo.
Il monastero domenicano.
Era considerato uno dei monasteri primari di Palermo; le religiose provenienti da nobili famiglie professavano la regola di San Domenico. Il monastero sorse dopo il 1311 per volontà testamentaria di B. Mastrangelo. Nel 1532, a causa dell'accrescersi del numero delle religiose, venne acquistata dal monastero la chiesa di San Matteo per ingrandire l'edificio. Nel XVII secolo il monastero era diventato per ricchezza ed estensione, uno dei più importanti della città e occupava ormai un'intero isolato. Il monastero subì diversi danneggiamenti sia durante i moti del 1848 e del 1860, che durante i bombardamenti del 1943.
Le ultime religiose hanno lasciato il monastero nel 2014 e oggi è aperto al pubblico e gestito dalla curia. La proprietà è del FEC (Fondo Edifici Culto).
Dal 2018 ospita la mostra "Sacra et Pretiosa".
Al suo interno si trova la dolceria, dove vengono riprodotti i dolci di svariati monasteri di Palermo secondo le antiche ricette delle suore.
Realizzata nel 1554 dallo scultore toscano Francesco Camilliani per ornare una villa fiorentina. Successivamente, fu acquistata dal Senato palermitano per la cifra di 20/30.000 scudi ed arrivò a Palermo smontata in 644 pezzi e ricomposta in maniera diversa rispetto al disegno originario.
La fontana ha impianto ellittico con vasche concentriche, disposte su tre livelli; scale e statue si alternano secondo uno schema classico e simmetrico. La fontana, prevista per uno spazio diverso dall’attuale collocazione, venne adattata da Camillo Camilliani, figlio di Francesco.
Le quattro vasche del primo livello, con gruppi statuari di figure giacenti, rappresentano i fiumi palermitani: Oreto, Papireto, Gabriele e Maredolce; nella cancellata di recinzione sono riprodotti i volti del Genio di Palermo, Santa Rosalia e l'Aquila pretoria. Un ricco repertorio plastico di statue rappresentano divinità mitologiche, mostri, animali, delfini, arpie e sirene.
La palese nudità delle figure esposte non mancarono di turbare l’animo dei cittadini che ribattezzarono questo sito, “Piazza della Vergogne”. La cancellata, disegnata da Giovan Battista Filippo Basile, fu collocata nel 1858.
Commissionata dal nobile spagnolo Don Luigi de Toledo a Francesco Camilliani, è stata realizzata nel 1554 per la sua villa fiorentina. Una ventina d’anni dopo, a causa dei debiti della famiglia Toledo, la fontana venne venduta al senato palermitano che la acquistò per ben 30 mila scudi. Questa spesa enorme, fatta in un momento in cui a Palermo regnavano miseria e carestia, rese in poco tempo il monumento il simbolo della corruzione e del malcostume di alcuni rappresentanti della vita civile e politica, facendole guadagnare, secondo la versione più accreditata, l’appellativo di Fontana della Vergogna.
Ma le storie sull’origine di questo soprannome sono molteplici: una seconda versione fa risalire l’appellativo alle vicende delle suore del convento antistante, costrette soventemente a coprirsi il viso per non osservare la nudità delle statue (c’è chi narra che una notte, le suore del convento andarono a distruggere le parti sessuali maschili stanche di dover tollerare quella visuale).
La fontana giunse a Palermo il 26 maggio 1574 smontata in 644 pezzi, di cui alcuni mancanti. Alcune sculture si rovinarono durante il trasporto e altre furono trattenute dal proprietario.
Il complesso monumentale, ricco di statue di marmo di Carrara è costituito da tre livelli colmi di significati simbolici.
Nella base si trovano 4 vasche sul cui bordo giacciono statue allegoriche dei fiumi di Palermo, ovvero l’Oreto, il Papireto, il Gabriele e il Maredolce. Ogni vasca è fiancheggiata da altrettante statue di tritoni, nereidi e sirene.
La scalinata che porta al secondo livello presenta una fascia di nicchie con teste di animali e mostri mitologici dalla cui bocca sgorga acqua. Questo settore è ricco di figure mitologiche, tra cui si riconoscono Venere, Adone, Ercole, Apollo, Diana e Pomona.
Al terzo livello si trova una vasca più piccola sovrastata dalla statua di Bacco.
Il poeta monrealese Antonio Veneziano, a cui è stato affidato il compito di reinterpretare in chiave locale gli aspetti mitologici dell’opera, identificò la statua sovrastante come il Genio di Palermo, nume tutelare della città insieme a Santa Rosalia.
Il complesso monumentale è ricco di significati nascosti. Le 8 statue poste alle estremità della fontana, ad esempio, oltre a delimitare i margini fisici e materiali sono simbolo dei confini dello spazio ed il tempo, una sorta di porta celeste che consente l’accesso alla Gerusalemme celeste.
A Camilliani si ispirò probabilmente Bernini che circa cento anni dopo, a Roma, in piazza Navona, realizzò la fontana dei quattro fiumi, nella quale quattro statue raffigurano i principali fiumi di 4 continenti: il Gange per l’Asia, il Rio della Plata in America, il Danubio per l’Europa, il Nilo per l’Africa.
La cancellata in ferro battuto che racchiude la fontana fu realizzata nel 1858 dall’Arch. Giovanni Battista Filippo Basile.
99 Recomendado por los habitantes de la zona
Fontana Pretoria
Piazza PretoriaRealizzata nel 1554 dallo scultore toscano Francesco Camilliani per ornare una villa fiorentina. Successivamente, fu acquistata dal Senato palermitano per la cifra di 20/30.000 scudi ed arrivò a Palermo smontata in 644 pezzi e ricomposta in maniera diversa rispetto al disegno originario.
La fontana ha impianto ellittico con vasche concentriche, disposte su tre livelli; scale e statue si alternano secondo uno schema classico e simmetrico. La fontana, prevista per uno spazio diverso dall’attuale collocazione, venne adattata da Camillo Camilliani, figlio di Francesco.
Le quattro vasche del primo livello, con gruppi statuari di figure giacenti, rappresentano i fiumi palermitani: Oreto, Papireto, Gabriele e Maredolce; nella cancellata di recinzione sono riprodotti i volti del Genio di Palermo, Santa Rosalia e l'Aquila pretoria. Un ricco repertorio plastico di statue rappresentano divinità mitologiche, mostri, animali, delfini, arpie e sirene.
La palese nudità delle figure esposte non mancarono di turbare l’animo dei cittadini che ribattezzarono questo sito, “Piazza della Vergogne”. La cancellata, disegnata da Giovan Battista Filippo Basile, fu collocata nel 1858.
Commissionata dal nobile spagnolo Don Luigi de Toledo a Francesco Camilliani, è stata realizzata nel 1554 per la sua villa fiorentina. Una ventina d’anni dopo, a causa dei debiti della famiglia Toledo, la fontana venne venduta al senato palermitano che la acquistò per ben 30 mila scudi. Questa spesa enorme, fatta in un momento in cui a Palermo regnavano miseria e carestia, rese in poco tempo il monumento il simbolo della corruzione e del malcostume di alcuni rappresentanti della vita civile e politica, facendole guadagnare, secondo la versione più accreditata, l’appellativo di Fontana della Vergogna.
Ma le storie sull’origine di questo soprannome sono molteplici: una seconda versione fa risalire l’appellativo alle vicende delle suore del convento antistante, costrette soventemente a coprirsi il viso per non osservare la nudità delle statue (c’è chi narra che una notte, le suore del convento andarono a distruggere le parti sessuali maschili stanche di dover tollerare quella visuale).
La fontana giunse a Palermo il 26 maggio 1574 smontata in 644 pezzi, di cui alcuni mancanti. Alcune sculture si rovinarono durante il trasporto e altre furono trattenute dal proprietario.
Il complesso monumentale, ricco di statue di marmo di Carrara è costituito da tre livelli colmi di significati simbolici.
Nella base si trovano 4 vasche sul cui bordo giacciono statue allegoriche dei fiumi di Palermo, ovvero l’Oreto, il Papireto, il Gabriele e il Maredolce. Ogni vasca è fiancheggiata da altrettante statue di tritoni, nereidi e sirene.
La scalinata che porta al secondo livello presenta una fascia di nicchie con teste di animali e mostri mitologici dalla cui bocca sgorga acqua. Questo settore è ricco di figure mitologiche, tra cui si riconoscono Venere, Adone, Ercole, Apollo, Diana e Pomona.
Al terzo livello si trova una vasca più piccola sovrastata dalla statua di Bacco.
Il poeta monrealese Antonio Veneziano, a cui è stato affidato il compito di reinterpretare in chiave locale gli aspetti mitologici dell’opera, identificò la statua sovrastante come il Genio di Palermo, nume tutelare della città insieme a Santa Rosalia.
Il complesso monumentale è ricco di significati nascosti. Le 8 statue poste alle estremità della fontana, ad esempio, oltre a delimitare i margini fisici e materiali sono simbolo dei confini dello spazio ed il tempo, una sorta di porta celeste che consente l’accesso alla Gerusalemme celeste.
A Camilliani si ispirò probabilmente Bernini che circa cento anni dopo, a Roma, in piazza Navona, realizzò la fontana dei quattro fiumi, nella quale quattro statue raffigurano i principali fiumi di 4 continenti: il Gange per l’Asia, il Rio della Plata in America, il Danubio per l’Europa, il Nilo per l’Africa.
La cancellata in ferro battuto che racchiude la fontana fu realizzata nel 1858 dall’Arch. Giovanni Battista Filippo Basile.
Situata in posizione dominante la sottostante piazza Bellini, la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, nota anche come “la Martorana“, deve la sua più comune denominazione alla presenza di un monastero benedettino femminile, fondato nel 1193 da Goffredo ed Aloisia de Marturano, al quale nel 1435 il re Alfonso “il Magnanimo” concesse la chiesa.
La sua edificazione (1143-1185), si deve al grande Ammiraglio del Regno, Giorgio Antiocheno, come ringraziamento per l’aiuto e la protezione concessagli dalla Santissima Vergine: il famoso Ammiraglio, volle assegnare la chiesa al clero greco bizantino, stabilendone anche la dotazione (un fondo in Misilmeri con 10 villani).
Nel 1282 dopo la rivolta del Vespro, nella chiesa ebbe luogo la riunione dei maggiori baroni del Regno, in cui si giurò fedeltà a Pietro d’Aragona che aveva appoggiato la rivolta contro Carlo d’Angiò.
L’aspetto attuale, dovuto alle aggiunte di epoca barocca, in parte eliminati dai restauri ottocenteschi operati dall’ingegnere Giuseppe Patricolo (1870-1873), rivela chiaramente il contrasto tra la facciata barocca e la superficie muraria della originaria costruzione normanna, facilmente riconoscibile dai caratteri inconfondibili dell’architettura ecclesiale del medioevo siciliano: il disegno delle arcate, le finestrelle ogivali, la muratura eseguita con filari di piccoli conci ben squadrati e la presenza della cupola.
L’interno, vero gioiello dell’arte bizantina, è a croce greca inscritta in un quadrato, con i bracci della croce coperti a botte e gli ambienti sulle diagonali coperti da volte a crociera. Al centro quattro colonne collegate da archi moderatamente ogivali sorreggono un tamburo ottagonale con pennacchi a nicchie rientranti, sul quale imposta la calotta emisferica della cupola.
Preziosissimo è l’apparato musivo interno, tra i più antichi in Sicilia, portato a compimento da maestranze bizantine prima del 1151 (data approssimativa della morte del committente) in gran parte sopravvissuto alle successive manomissioni.
I quadri che costituiscono la decorazione musiva seguono una rigorosa disposizione, rispondente al programma liturgico che li presuppone.
La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 con il contributo di un biglietto d’ingresso.
La messa viene celebrata la domenica alle ore11:00
342 Recomendado por los habitantes de la zona
Santa Maria dell'Ammiraglio (La Martorana)
3 Piazza BelliniSituata in posizione dominante la sottostante piazza Bellini, la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, nota anche come “la Martorana“, deve la sua più comune denominazione alla presenza di un monastero benedettino femminile, fondato nel 1193 da Goffredo ed Aloisia de Marturano, al quale nel 1435 il re Alfonso “il Magnanimo” concesse la chiesa.
La sua edificazione (1143-1185), si deve al grande Ammiraglio del Regno, Giorgio Antiocheno, come ringraziamento per l’aiuto e la protezione concessagli dalla Santissima Vergine: il famoso Ammiraglio, volle assegnare la chiesa al clero greco bizantino, stabilendone anche la dotazione (un fondo in Misilmeri con 10 villani).
Nel 1282 dopo la rivolta del Vespro, nella chiesa ebbe luogo la riunione dei maggiori baroni del Regno, in cui si giurò fedeltà a Pietro d’Aragona che aveva appoggiato la rivolta contro Carlo d’Angiò.
L’aspetto attuale, dovuto alle aggiunte di epoca barocca, in parte eliminati dai restauri ottocenteschi operati dall’ingegnere Giuseppe Patricolo (1870-1873), rivela chiaramente il contrasto tra la facciata barocca e la superficie muraria della originaria costruzione normanna, facilmente riconoscibile dai caratteri inconfondibili dell’architettura ecclesiale del medioevo siciliano: il disegno delle arcate, le finestrelle ogivali, la muratura eseguita con filari di piccoli conci ben squadrati e la presenza della cupola.
L’interno, vero gioiello dell’arte bizantina, è a croce greca inscritta in un quadrato, con i bracci della croce coperti a botte e gli ambienti sulle diagonali coperti da volte a crociera. Al centro quattro colonne collegate da archi moderatamente ogivali sorreggono un tamburo ottagonale con pennacchi a nicchie rientranti, sul quale imposta la calotta emisferica della cupola.
Preziosissimo è l’apparato musivo interno, tra i più antichi in Sicilia, portato a compimento da maestranze bizantine prima del 1151 (data approssimativa della morte del committente) in gran parte sopravvissuto alle successive manomissioni.
I quadri che costituiscono la decorazione musiva seguono una rigorosa disposizione, rispondente al programma liturgico che li presuppone.
La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 con il contributo di un biglietto d’ingresso.
La messa viene celebrata la domenica alle ore11:00
La Chiesa del Gesù, meglio conosciuta con il nome di Casa Professa, costruita nel 1564 dai padri Gesuiti rappresenta, sicuramente, l’esempio più significativo dell’arte barocca a Palermo. Malgrado avesse inglobato parte delle precedenti strutture, la nuova chiesa risultò di forme sontuose e nel 1683 fu completata la cupola.
Alla decorazione si lavorò dal 1658 fino a tutto il XVIII secolo. A partire dal 1703 si diede inizio ad una nuova fase della decorazione dei soffitti e delle volte; gli stucchi furono eseguiti da Procopio Serpotta, mentre gli affreschi furono opera di Antonio Grano. La facciata, su disegno tardo cinquecentesco, è posta su una gradinata; sulle aperture sono state collocate delle nicchie che ospitano le statue della Vergine della Grotta col Gesù, S. Ignazio e S. Francesco.
L’interno, grandioso, è a croce latina con tre navate e profonde cappelle laterali intercomunicabili. La dimensione imponente e l’esuberante decorazione, che ricopre senza soluzione di continuità tutta la superficie, ne fanno un insieme di incredibile espressività barocca; infatti, l’interno della chiesa è uno dei più rappresentativi ed omogenei prodotti della decorazione detta “a marmi mischi”. Al primo piano è collocato l’Oratorio del Sabato decorato da pregevoli stucchi del 1740 realizzati da Procopio Serpotta e da un affresco, posto sulla volta che rappresenta l’Incoronazione della Vergine eseguito da Filippo Randazzo. Inoltre è possibile visitare il Museo, il quale si estende su più livelli. Nelle varie sale tematiche dedicate al "Tesoro dei Gesuiti" sono esposti molti arredi sacri, pregevoli paliotti, raffinati astensori e varie suppellettili in corallo e argento della produzione artigianale trapanese del sec. XVII e XVIII.
178 Recomendado por los habitantes de la zona
Iglesia del Gesu
21 Piazza Casa ProfessaLa Chiesa del Gesù, meglio conosciuta con il nome di Casa Professa, costruita nel 1564 dai padri Gesuiti rappresenta, sicuramente, l’esempio più significativo dell’arte barocca a Palermo. Malgrado avesse inglobato parte delle precedenti strutture, la nuova chiesa risultò di forme sontuose e nel 1683 fu completata la cupola.
Alla decorazione si lavorò dal 1658 fino a tutto il XVIII secolo. A partire dal 1703 si diede inizio ad una nuova fase della decorazione dei soffitti e delle volte; gli stucchi furono eseguiti da Procopio Serpotta, mentre gli affreschi furono opera di Antonio Grano. La facciata, su disegno tardo cinquecentesco, è posta su una gradinata; sulle aperture sono state collocate delle nicchie che ospitano le statue della Vergine della Grotta col Gesù, S. Ignazio e S. Francesco.
L’interno, grandioso, è a croce latina con tre navate e profonde cappelle laterali intercomunicabili. La dimensione imponente e l’esuberante decorazione, che ricopre senza soluzione di continuità tutta la superficie, ne fanno un insieme di incredibile espressività barocca; infatti, l’interno della chiesa è uno dei più rappresentativi ed omogenei prodotti della decorazione detta “a marmi mischi”. Al primo piano è collocato l’Oratorio del Sabato decorato da pregevoli stucchi del 1740 realizzati da Procopio Serpotta e da un affresco, posto sulla volta che rappresenta l’Incoronazione della Vergine eseguito da Filippo Randazzo. Inoltre è possibile visitare il Museo, il quale si estende su più livelli. Nelle varie sale tematiche dedicate al "Tesoro dei Gesuiti" sono esposti molti arredi sacri, pregevoli paliotti, raffinati astensori e varie suppellettili in corallo e argento della produzione artigianale trapanese del sec. XVII e XVIII.
Intitolata Maria Ss. Assunta, nel luogo dove fu costruita esisteva una chiesa preislamica divenuta in epoca musulmana la grande moschea delle adunanze (Gami). L'edificazione del complesso fu eseguita durante il mandato vescovile di Gualtiero Offamilio, membro della famiglia reale e arcivescovo della diocesi di Palermo tra il 1169 e il 1190. La chiesa fu compiuta in brevissimo tempo tra il 1179 e il 1185, al termine del regno di Guglielmo II, ultimo re normanno, e rappresenta il culmine culturale e artistico di quell'epoca.
746 Recomendado por los habitantes de la zona
Catedral de Palermo
490 Via Vittorio EmanueleIntitolata Maria Ss. Assunta, nel luogo dove fu costruita esisteva una chiesa preislamica divenuta in epoca musulmana la grande moschea delle adunanze (Gami). L'edificazione del complesso fu eseguita durante il mandato vescovile di Gualtiero Offamilio, membro della famiglia reale e arcivescovo della diocesi di Palermo tra il 1169 e il 1190. La chiesa fu compiuta in brevissimo tempo tra il 1179 e il 1185, al termine del regno di Guglielmo II, ultimo re normanno, e rappresenta il culmine culturale e artistico di quell'epoca.
Il Palazzo Reale
Il cuore dell’itinerario arabo-normanno è il Palazzo Reale, monumento simbolo della ricchezza, del potere politico e della cultura del regno normanno; al suo interno, custodita come un tesoro, si trova la Cappella Palatina: “la più bella che esiste al mondo, il più stupendo gioiello religioso vagheggiato dal pensiero umano ed eseguito da mani d’artista” (Guy de Maupassant).
Dopo l’incoronazione del 1130, Ruggero II ordinò la costruzione della Cappella del Palazzo. Essa rappresenta sul piano architettonico e decorativo, l’incontro tra culture e religioni diverse, poiché furono coinvolte nella sua realizzazione maestranze bizantine, islamiche e latine.
I Giardini Reali
All’interno del Bastione di San Pietro, parte del progetto di riorganizzazione difensiva della città di Palermo del 1560 affidato all’architetto Antonio Ferramolino, si trovano i giardini del Palazzo Reale. All’interno spiccano tre Ficus macrophylla, uno dei quali abbraccia un grande Pinus pinea.
La Sala d’Ercole è il luogo nel quale si riuniscono, dal 1947, i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana. Prende il nome dalle pitture raffiguranti il ciclo dedicato all’eroe mitologico greco, completate all’inizio del XIX secolo dall’artista Giuseppe Velasco (detto il Velasquez).
L'ingresso al Palazzo è in Piazza del Parlamento.
Oltre alla Cappella Palatina e alla Mostra, nel percorso turistico sono incluse tutte le sale degli Appartamenti Reali con esclusione della Sala Pio La Torre e Sala Piersanti Mattarella.
L’offerta di visita monumentale si arricchisce della visita ai Giardini Reali. I fruitori del Complesso Monumentale, in modo facoltativo, potranno inserirlo nel percorso turistico.
Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì gli Appartamenti Reali sono interdetti al pubblico per lo svolgimento delle attività parlamentari, mentre resta visitabile la Cappella Palatina, ad eccezione di quando vi si celebrano le funzioni religiose.
ORARI DI APERTURA DEL COMPLESSO MONUMENTALE
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 16,30 (ultimo ingresso);
Domenica e festivi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (ultimo ingresso).
Il Complesso Monumentale rimarrà chiuso: 25 dicembre e 1 gennaio.
494 Recomendado por los habitantes de la zona
Palacio de los Normandos
1 Piazza del ParlamentoIl Palazzo Reale
Il cuore dell’itinerario arabo-normanno è il Palazzo Reale, monumento simbolo della ricchezza, del potere politico e della cultura del regno normanno; al suo interno, custodita come un tesoro, si trova la Cappella Palatina: “la più bella che esiste al mondo, il più stupendo gioiello religioso vagheggiato dal pensiero umano ed eseguito da mani d’artista” (Guy de Maupassant).
Dopo l’incoronazione del 1130, Ruggero II ordinò la costruzione della Cappella del Palazzo. Essa rappresenta sul piano architettonico e decorativo, l’incontro tra culture e religioni diverse, poiché furono coinvolte nella sua realizzazione maestranze bizantine, islamiche e latine.
I Giardini Reali
All’interno del Bastione di San Pietro, parte del progetto di riorganizzazione difensiva della città di Palermo del 1560 affidato all’architetto Antonio Ferramolino, si trovano i giardini del Palazzo Reale. All’interno spiccano tre Ficus macrophylla, uno dei quali abbraccia un grande Pinus pinea.
La Sala d’Ercole è il luogo nel quale si riuniscono, dal 1947, i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana. Prende il nome dalle pitture raffiguranti il ciclo dedicato all’eroe mitologico greco, completate all’inizio del XIX secolo dall’artista Giuseppe Velasco (detto il Velasquez).
L'ingresso al Palazzo è in Piazza del Parlamento.
Oltre alla Cappella Palatina e alla Mostra, nel percorso turistico sono incluse tutte le sale degli Appartamenti Reali con esclusione della Sala Pio La Torre e Sala Piersanti Mattarella.
L’offerta di visita monumentale si arricchisce della visita ai Giardini Reali. I fruitori del Complesso Monumentale, in modo facoltativo, potranno inserirlo nel percorso turistico.
Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì gli Appartamenti Reali sono interdetti al pubblico per lo svolgimento delle attività parlamentari, mentre resta visitabile la Cappella Palatina, ad eccezione di quando vi si celebrano le funzioni religiose.
ORARI DI APERTURA DEL COMPLESSO MONUMENTALE
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 16,30 (ultimo ingresso);
Domenica e festivi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (ultimo ingresso).
Il Complesso Monumentale rimarrà chiuso: 25 dicembre e 1 gennaio.
La Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, uno dei più insigni edifici medievali di Palermo e uno dei monumenti-simbolo della città, fu costruita in epoca normanna, tra il 1130 e il 1148, sotto il regno di Ruggero II, ma radicalmente restaurata nel 1882 da Giuseppe Patricolo.
Il modulo costruttivo interno della chiesa è dato da una struttura cubica sormontata da una cupola. Tale modulo si ripete cinque volte: due nelle campate dell’unica navata, tre nel transetto. L’accostamento del quadrato, che rappresenta la terra, al cerchio, che rappresenta il cielo, ricorre sia nella cultura islamica fatimita sia in quella bizantina. L’interno è nudo e raccolto.
La navata centrale è suddivisa trasversalmente da un robusto arco ogivale uguale all’altro che limita anteriormente il transetto. Questo ha tre absidi semicircolari delle quali solo la centrale si pronunzia all’esterno oltre la struttura del muro. Annesso alla chiesa, vi è il Chiostro, di datazione problematica, verosimilmente del XIII secolo. Esso si presenta di forma rettangolare, con gli archi a sesto acuto su colonnine binate.
155 Recomendado por los habitantes de la zona
San Giovanni degli Eremiti
16 Via dei BenedettiniLa Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, uno dei più insigni edifici medievali di Palermo e uno dei monumenti-simbolo della città, fu costruita in epoca normanna, tra il 1130 e il 1148, sotto il regno di Ruggero II, ma radicalmente restaurata nel 1882 da Giuseppe Patricolo.
Il modulo costruttivo interno della chiesa è dato da una struttura cubica sormontata da una cupola. Tale modulo si ripete cinque volte: due nelle campate dell’unica navata, tre nel transetto. L’accostamento del quadrato, che rappresenta la terra, al cerchio, che rappresenta il cielo, ricorre sia nella cultura islamica fatimita sia in quella bizantina. L’interno è nudo e raccolto.
La navata centrale è suddivisa trasversalmente da un robusto arco ogivale uguale all’altro che limita anteriormente il transetto. Questo ha tre absidi semicircolari delle quali solo la centrale si pronunzia all’esterno oltre la struttura del muro. Annesso alla chiesa, vi è il Chiostro, di datazione problematica, verosimilmente del XIII secolo. Esso si presenta di forma rettangolare, con gli archi a sesto acuto su colonnine binate.
Un tempo la città di Palermo era circondata da mura e vi erano anche delle porte di ingresso, la più importante era la Porta detta del Palazzo.
Questa Porta fu chiusa forse nel 1460 e ne fu costruita un’altra all’estremità della strada principale e fu chiamata Porta dell’Aquila, ma la popolazione la chiamò subito Porta Nuova.
Carlo V d’Asburgo, re di Italia, re di Spagna e imperatore del sacro impero romano-germanico, giunse in Sicilia vittorioso da Tunisi nell’autunno del 1535, dopo aver conquistato la costa africana del Mediterraneo e aver così colpito l’islam.
Questa vittoria fu così importante per i Siciliani, che Carlo V fu costretto a rimanere otto giorni a Monreale, più di quanto avesse previsto, perché così supplicato dalla città di Palermo, che aveva voluto un’intera settimana per preparare solenni onoranze al vincitore d’Africa.
La festa fu celebrata il 13 settembre 1535 e sotto la Porta Nuova avvenne l’incontro ufficiale di Carlo V con la capitale del regno.
A ricordo di questo momento, il governo di Marcoantonio Colonna, viceré di Sicilia, decise di riedificare la Porta, i cui lavori cominciarono in ritardo e cioè nel 1583. Il viceré volle che la porta si chiamasse “Austriaca” in onore di Carlo V.
Ma anche questa Porta a guisa di arco trionfale non ebbe molta fortuna: il 20 dicembre del 1667, durante un temporale, un fulmine fece esplodere un carico di munizioni depositate in alcune stanze del piano superiore, provocando gravissimi danni.
La porta venne subito ricostruita nel 1669 nelle stesse forme da Gaspare Guercio, architetto del senato.
Ha due facciate, una che guarda il centro storico e l’altra rivolta verso Monreale.
Essa fu ornata di fregi e di simboli tra cui quattro turchi sconfitti. Due dei quali con le braccia mozzate, le braccia infatti venivano mozzate a coloro ai quali veniva imputato il reato di furto; e due con le braccia incrociate segno di sottomissione, a ricordo della vittoria Africana.
La manieristica costruzione si ispira ai monumenti trionfali romani antichi ma anche alla tarda architettura rinascimentale con larghi influssi manieristici. Nella facciata interna si possono ammirare quattro busti allegorici della Pace, della Giustizia, della Verità, e dell’ abbondanza.
Inoltre sopra l’arco si vede l’aquila palermitana e lo stemma del viceré Colonna.
Alzando lo sguardo vi è un loggiato cinquecentesco e una straordinaria copertura a piramide rivestita di maiolica colorata sulla quale vi è raffigurata l’aquila senatoria con le ali spiegate, simbolo della città di Palermo.
In cima vi è un lanternino dentro il quale vi è una stanza che ha per volta un cupolino coperto di piombo che terminava con tre palle di rame, la più piccola delle quali aveva una banderuola di ferro destinata ad indicare lo spirare dei venti.
Nel 1578 il viceré Marcoantonio Colonna fece costruire un corridoio scoperto, fiancheggiato da una balaustra di pietra, che dal Palazzo Reale portava ad una stanza del secondo ordine di Porta Nuova. Ebbene, queste stanze all’interno della Porta furono testimoni di una intrigata e adulterina storia di passione e di amore. Protagonista fu proprio il viceré, quando ormai non più giovane, conobbe ad un ricevimento in suo onore la giovane Eufrosina Siracusa Valdaura, baronessa del Miserendino e rimase stregato dalla sua eccezionale bellezza.
Entrambi erano sposati, ma furono travolti dalla passione con risvolti tragici che i cronisti del tempo raccontarono con dovizia di particolari.
50 Recomendado por los habitantes de la zona
Porta Nuova
475 Via Vittorio EmanueleUn tempo la città di Palermo era circondata da mura e vi erano anche delle porte di ingresso, la più importante era la Porta detta del Palazzo.
Questa Porta fu chiusa forse nel 1460 e ne fu costruita un’altra all’estremità della strada principale e fu chiamata Porta dell’Aquila, ma la popolazione la chiamò subito Porta Nuova.
Carlo V d’Asburgo, re di Italia, re di Spagna e imperatore del sacro impero romano-germanico, giunse in Sicilia vittorioso da Tunisi nell’autunno del 1535, dopo aver conquistato la costa africana del Mediterraneo e aver così colpito l’islam.
Questa vittoria fu così importante per i Siciliani, che Carlo V fu costretto a rimanere otto giorni a Monreale, più di quanto avesse previsto, perché così supplicato dalla città di Palermo, che aveva voluto un’intera settimana per preparare solenni onoranze al vincitore d’Africa.
La festa fu celebrata il 13 settembre 1535 e sotto la Porta Nuova avvenne l’incontro ufficiale di Carlo V con la capitale del regno.
A ricordo di questo momento, il governo di Marcoantonio Colonna, viceré di Sicilia, decise di riedificare la Porta, i cui lavori cominciarono in ritardo e cioè nel 1583. Il viceré volle che la porta si chiamasse “Austriaca” in onore di Carlo V.
Ma anche questa Porta a guisa di arco trionfale non ebbe molta fortuna: il 20 dicembre del 1667, durante un temporale, un fulmine fece esplodere un carico di munizioni depositate in alcune stanze del piano superiore, provocando gravissimi danni.
La porta venne subito ricostruita nel 1669 nelle stesse forme da Gaspare Guercio, architetto del senato.
Ha due facciate, una che guarda il centro storico e l’altra rivolta verso Monreale.
Essa fu ornata di fregi e di simboli tra cui quattro turchi sconfitti. Due dei quali con le braccia mozzate, le braccia infatti venivano mozzate a coloro ai quali veniva imputato il reato di furto; e due con le braccia incrociate segno di sottomissione, a ricordo della vittoria Africana.
La manieristica costruzione si ispira ai monumenti trionfali romani antichi ma anche alla tarda architettura rinascimentale con larghi influssi manieristici. Nella facciata interna si possono ammirare quattro busti allegorici della Pace, della Giustizia, della Verità, e dell’ abbondanza.
Inoltre sopra l’arco si vede l’aquila palermitana e lo stemma del viceré Colonna.
Alzando lo sguardo vi è un loggiato cinquecentesco e una straordinaria copertura a piramide rivestita di maiolica colorata sulla quale vi è raffigurata l’aquila senatoria con le ali spiegate, simbolo della città di Palermo.
In cima vi è un lanternino dentro il quale vi è una stanza che ha per volta un cupolino coperto di piombo che terminava con tre palle di rame, la più piccola delle quali aveva una banderuola di ferro destinata ad indicare lo spirare dei venti.
Nel 1578 il viceré Marcoantonio Colonna fece costruire un corridoio scoperto, fiancheggiato da una balaustra di pietra, che dal Palazzo Reale portava ad una stanza del secondo ordine di Porta Nuova. Ebbene, queste stanze all’interno della Porta furono testimoni di una intrigata e adulterina storia di passione e di amore. Protagonista fu proprio il viceré, quando ormai non più giovane, conobbe ad un ricevimento in suo onore la giovane Eufrosina Siracusa Valdaura, baronessa del Miserendino e rimase stregato dalla sua eccezionale bellezza.
Entrambi erano sposati, ma furono travolti dalla passione con risvolti tragici che i cronisti del tempo raccontarono con dovizia di particolari.
l palazzo, iniziato durante il regno di Guglielmo I ed ultimato da Guglielmo II intorno al 1167, fu la residenza estiva preferita dai re e dalla sua corte. Il suo nome deriva dall’arabo “al-Aziz”, ovvero “splendido”. Durante i secoli ha subito diverse trasformazioni, la più rilevante è sicuramente quella avvenuta nel 1635, dove vi furono apportate aggiunte in stile barocco, ad opera di Giovanni Sandoval.
Esternamente si presenta come un blocco cristallino suddiviso in tre ordini orizzontali corrispondenti ai tre piani. Sulla facciata principale si apre un vestibolo detto “Sala della fontana”, attorno a cui ruotano gli appartamenti delle ali meridionali e settentrionali e la cui decorazione è di ispirazione tipicamente islamica a pianta quadrangolare trilobata, retto da coppie di colonne; sull’arco di ingresso, invece, è stato collocato un affresco barocco detto “diavoli della Zisa”, ovvero una serie di figure che secondo la tradizione è impossibile contare per la loro disposizione in senso rotatorio.
Il pavimento della sala è attraversato da una canaletta che forma due vasche, quadrate all’esterno e ottagonali all’interno, in cui scorreva l’acqua versata dalla fontana, posta sulla parete di fondo. La sala è interamente coperta da un rivestimento in marmo sovrastato da una fascia a mosaico a motivi naturalistici, con tondi nella parete della fontana.
Di notevole interesse è il particolare sistema di ventilazione, costituito da camini che consentivano il refrigerio estivo. All’interno del castello è ospitato il Museo d’arte islamica, con reperti provenienti dall’area del Mediterraneo.
212 Recomendado por los habitantes de la zona
Castillo de la Zisa
Piazza Zisal palazzo, iniziato durante il regno di Guglielmo I ed ultimato da Guglielmo II intorno al 1167, fu la residenza estiva preferita dai re e dalla sua corte. Il suo nome deriva dall’arabo “al-Aziz”, ovvero “splendido”. Durante i secoli ha subito diverse trasformazioni, la più rilevante è sicuramente quella avvenuta nel 1635, dove vi furono apportate aggiunte in stile barocco, ad opera di Giovanni Sandoval.
Esternamente si presenta come un blocco cristallino suddiviso in tre ordini orizzontali corrispondenti ai tre piani. Sulla facciata principale si apre un vestibolo detto “Sala della fontana”, attorno a cui ruotano gli appartamenti delle ali meridionali e settentrionali e la cui decorazione è di ispirazione tipicamente islamica a pianta quadrangolare trilobata, retto da coppie di colonne; sull’arco di ingresso, invece, è stato collocato un affresco barocco detto “diavoli della Zisa”, ovvero una serie di figure che secondo la tradizione è impossibile contare per la loro disposizione in senso rotatorio.
Il pavimento della sala è attraversato da una canaletta che forma due vasche, quadrate all’esterno e ottagonali all’interno, in cui scorreva l’acqua versata dalla fontana, posta sulla parete di fondo. La sala è interamente coperta da un rivestimento in marmo sovrastato da una fascia a mosaico a motivi naturalistici, con tondi nella parete della fontana.
Di notevole interesse è il particolare sistema di ventilazione, costituito da camini che consentivano il refrigerio estivo. All’interno del castello è ospitato il Museo d’arte islamica, con reperti provenienti dall’area del Mediterraneo.
Uno dei teatri lirici più belli al mondo! Il teatro Massimo Vittorio Emanuele fu costruito in più di vent'anni, dl 1875 al 1897. Copre un'area di 7730 mq ed è stimato il terzo tetro d'Europa tra quelli ottocenteschi.
Il Teatro è aperto per le visite tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30).
834 Recomendado por los habitantes de la zona
Teatro Massimo
Piazza Giuseppe VerdiUno dei teatri lirici più belli al mondo! Il teatro Massimo Vittorio Emanuele fu costruito in più di vent'anni, dl 1875 al 1897. Copre un'area di 7730 mq ed è stimato il terzo tetro d'Europa tra quelli ottocenteschi.
Il Teatro è aperto per le visite tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00 (ultima visita alle 18:30).
Il Museo è ubicato nel complesso architettonico della congregazione dei Padri Filippini all’Olivella, risalente al XVII secolo. Il suo patrimonio illustra le diverse fasi dell'arte e della civiltà della Sicilia occidentale, dalla preistoria al medioevo. Il Museo accoglie prestigiosi esempi del collezionismo settecentesco e ottocentesco, anche di provenienza non siciliana, come la Collezione etrusca Casuccini, reperti rinvenuti nel corso delle campagne di scavo nell’isola, grazie all'infaticabile attività di Antonino Salinas (1841-1914) cui è dedicato l'Istituto.
Orari:
Dal martedì al sabato ore 9.00-19.00 - ultimo ingresso ore 18.30;
Domenica e festivi ore 9.00-13.30 - ultimo ingresso ore 13.00.
Lunedì riposo settimanale.
173 Recomendado por los habitantes de la zona
Museo Arqueológico Regional Antonio Salinas
Piazza OlivellaIl Museo è ubicato nel complesso architettonico della congregazione dei Padri Filippini all’Olivella, risalente al XVII secolo. Il suo patrimonio illustra le diverse fasi dell'arte e della civiltà della Sicilia occidentale, dalla preistoria al medioevo. Il Museo accoglie prestigiosi esempi del collezionismo settecentesco e ottocentesco, anche di provenienza non siciliana, come la Collezione etrusca Casuccini, reperti rinvenuti nel corso delle campagne di scavo nell’isola, grazie all'infaticabile attività di Antonino Salinas (1841-1914) cui è dedicato l'Istituto.
Orari:
Dal martedì al sabato ore 9.00-19.00 - ultimo ingresso ore 18.30;
Domenica e festivi ore 9.00-13.30 - ultimo ingresso ore 13.00.
Lunedì riposo settimanale.
Fu costruita tra il 1598 e il 1622 dai Padri Filippini, stabilitisi a Palermo nel 1594, su progetto di Antonio Muttone. La facciata, completata tra il 1655 ed il 1690, è caratterizzata dalla presenza di due torri campanarie gemelle, da una profusione di colonne, lievemente aggettanti, da portali e statue che, sull’esempio di coeve realizzazioni romane, trasformarono la facciata della chiesa in un magnifico e sontuoso documento barocco. Una larga gradinata, racchiusa da cancellata in ferro, conduce ai portali, eseguiti intorno al 1690, con porte lignee di fine intaglio.
Le statue del secondo ordine raffigurano: S. Rosalia e S. Filippo Neri, sul campanile di destra, S. Francesco di Sales e S. Ignazio, a sinistra. L’edificio è sormontato da una elegante cupola terminata nel 1732 e ricoperta da lamine di piombo. L’interno, a triplice navata, è ampio e solenne ed ha una pianta a croce latina. Le navate sono distribuite da colonne e completate da cappelle laterali; il vasto transetto introduce al cappellone rettangolare. La decorazione, eseguita durante il XVIII secolo, include importanti opere pittoriche e scultoree.
Di grande pregio è il pavimento costituito da un’elegante composizione di marmi policromi. La volta fu decorata da Antonio Manno nel 1790 con scene tratte dalla Sacra Scrittura; gli scomparti neoclassici furono predisposti da Venanzio Marvuglia, che collaborò all’ultima sistemazione della chiesa intorno al 1772. Inoltre, di notevole interesse sono: statua dell’Immacolata realizzata da Alessandro Bagnasco nel 1873; tela di S. Rosalia eseguita da Filippo Randazzo; due cantorie con organo che affiancano la tribuna decorata da pannelli in marmo; l’altare maggiore del XIX secolo in marmo con pietre e fregi bronzei e affiancato da due statue in marmo eseguite da Ignazio Marabitti raffiguranti S. Pietro e S. Paolo etc.
Church of St. Ignatius at Olivella
1 Piazza OlivellaFu costruita tra il 1598 e il 1622 dai Padri Filippini, stabilitisi a Palermo nel 1594, su progetto di Antonio Muttone. La facciata, completata tra il 1655 ed il 1690, è caratterizzata dalla presenza di due torri campanarie gemelle, da una profusione di colonne, lievemente aggettanti, da portali e statue che, sull’esempio di coeve realizzazioni romane, trasformarono la facciata della chiesa in un magnifico e sontuoso documento barocco. Una larga gradinata, racchiusa da cancellata in ferro, conduce ai portali, eseguiti intorno al 1690, con porte lignee di fine intaglio.
Le statue del secondo ordine raffigurano: S. Rosalia e S. Filippo Neri, sul campanile di destra, S. Francesco di Sales e S. Ignazio, a sinistra. L’edificio è sormontato da una elegante cupola terminata nel 1732 e ricoperta da lamine di piombo. L’interno, a triplice navata, è ampio e solenne ed ha una pianta a croce latina. Le navate sono distribuite da colonne e completate da cappelle laterali; il vasto transetto introduce al cappellone rettangolare. La decorazione, eseguita durante il XVIII secolo, include importanti opere pittoriche e scultoree.
Di grande pregio è il pavimento costituito da un’elegante composizione di marmi policromi. La volta fu decorata da Antonio Manno nel 1790 con scene tratte dalla Sacra Scrittura; gli scomparti neoclassici furono predisposti da Venanzio Marvuglia, che collaborò all’ultima sistemazione della chiesa intorno al 1772. Inoltre, di notevole interesse sono: statua dell’Immacolata realizzata da Alessandro Bagnasco nel 1873; tela di S. Rosalia eseguita da Filippo Randazzo; due cantorie con organo che affiancano la tribuna decorata da pannelli in marmo; l’altare maggiore del XIX secolo in marmo con pietre e fregi bronzei e affiancato da due statue in marmo eseguite da Ignazio Marabitti raffiguranti S. Pietro e S. Paolo etc.
Il Palazzo delle Poste è un mausoleo fascista progettato dall’architetto bolognese Angiolo Mazzoni nei primi anni '20.
L'edificio, dopo ben 5 anni di lavori, fu inaugurato il 28 ottobre 1934 alla presenza dell'allora ministro delle Comunicazioni, Umberto Puppini.
Improntato ad un'architettura razionalista, il Palazzo delle Poste si erge su una grande scalinata in marmo di Billiemi, sormontata da dieci colonne con un ampio fregio, decorato da due "Fame" alate disegnate da Angiolo Mazzoni e simboleggianti le allegorie delle Comunicazioni. Ai lati del colonnato presenti anche due fontane.
L'interno dell'edificio è decorato con i più pregiati marmi italiani, le pitture e gli affreschi futuristi di Piero Bevilacqua, Benedetta Cappa (moglie di Filippo Tommaso Marinetti), Tato, le sculture di Corrado Vigni e Manlio Giardizzo e gli arredi di Brunas, Paolo Bevilacqua e Angiolo Mazzoni.
Dopo la caduta del governo fascista gli Alleati distrussero tutte le opere e le raffigurazioni inneggianti al governo fascista, incluso il grande Fascio Littorio di marmo bianco sul lato destro.
Il legame del palazzo con il regime ne causò un lungo periodo di decadimento, fino al danneggiamento a causa di un incendio nel 1988 ed ai lunghi ed accurati lavori di restauro che gli hanno restituito l'antica gloria.
Oggi il Palazzo assolve alla funzione di ufficio centrale delle Poste di Palermo ed i piani aperti al pubblico sono liberamente visitabili.
Palazzo delle Poste
320 Via RomaIl Palazzo delle Poste è un mausoleo fascista progettato dall’architetto bolognese Angiolo Mazzoni nei primi anni '20.
L'edificio, dopo ben 5 anni di lavori, fu inaugurato il 28 ottobre 1934 alla presenza dell'allora ministro delle Comunicazioni, Umberto Puppini.
Improntato ad un'architettura razionalista, il Palazzo delle Poste si erge su una grande scalinata in marmo di Billiemi, sormontata da dieci colonne con un ampio fregio, decorato da due "Fame" alate disegnate da Angiolo Mazzoni e simboleggianti le allegorie delle Comunicazioni. Ai lati del colonnato presenti anche due fontane.
L'interno dell'edificio è decorato con i più pregiati marmi italiani, le pitture e gli affreschi futuristi di Piero Bevilacqua, Benedetta Cappa (moglie di Filippo Tommaso Marinetti), Tato, le sculture di Corrado Vigni e Manlio Giardizzo e gli arredi di Brunas, Paolo Bevilacqua e Angiolo Mazzoni.
Dopo la caduta del governo fascista gli Alleati distrussero tutte le opere e le raffigurazioni inneggianti al governo fascista, incluso il grande Fascio Littorio di marmo bianco sul lato destro.
Il legame del palazzo con il regime ne causò un lungo periodo di decadimento, fino al danneggiamento a causa di un incendio nel 1988 ed ai lunghi ed accurati lavori di restauro che gli hanno restituito l'antica gloria.
Oggi il Palazzo assolve alla funzione di ufficio centrale delle Poste di Palermo ed i piani aperti al pubblico sono liberamente visitabili.
Aperto al pubblico nel maggio 2012, il Palazzo, che si sviluppa su 5.650 metri quadri di superficie, oltre ad ospitare gli uffici direzionali della Fondazione, offre spazio e fruibilità ad alcune prestigiose Collezioni della Fondazione stessa.
Al piano terra sono esposte la collezione archeologica della Cavallerizza e la collezione Mancini; al piano nobile sono custodite le collezioni filateliche, numismatiche, le sculture e le maioliche, insieme alla storica Biblioteca che conserva circa 50mila volumi della Fondazione. Da qui si può inoltre accedere ai suggestivi ambienti del Monte di Santa Rosalia, raro esempio ancora esistente di composizione architettonica lignea, destinata ora ad ospitare mostre d’arte temporanee.
A Palazzo Branciforte la cultura si coniuga anche con la buona tavola e con i sapori della tradizione mediterranea. In un’ala del piano terra è allestita la Città del Gusto, la celebre scuola di cucina del Gambero Rosso, rivolta sia ad un’utenza professionale che al più ampio pubblico degli appassionati. Attiguo alla scuola, in una straordinaria cornice architettonica è disponibile, anche fuori degli orari museali, il prestigioso Ristorante Branciforte.
L’Auditorium Branciforte attrezzato con le più moderne tecnologie può ospitare convegni ed eventi culturali, offrendo uno spazio esclusivo a chi desidera utilizzare il Palazzo per i propri incontri.
L’Emporio Branciforte propone al pubblico una selezionata offerta di prodotti editoriali e di oggettistica legati all’arte e alla enogastronomia.
Il coordinamento di tutte le attività, la gestione dei servizi museali e la promozione culturale di questo nuovo spazio sono affidati a Civita Sicilia.
La storia di Palazzo Branciforte ha un legame profondo con quella della città di Palermo fin da quando, nel XVII secolo, vi dimorava la famiglia di Nicolò Placido Branciforte Lanza conte di Raccuja.
Il nucleo originario del Palazzo è l’edificio costruito, con molta probabilità alla fine del Cinquecento, sull’area delimitata dalle odierne vie Bara, Lampedusa e Seminario Italo Albanese, il cui fronte principale prospettava sulla strada che allora collegava quelli che oggi sono i due ingressi principali.
Gli eredi del Conte di Raccuja, verso la metà del XVII secolo, ne avviarono l’ampliamento ottenendo dal Senato Palermitano di poter inglobare la strada antistante.
All’inizio del secolo successivo, completati i lavori che ne avevano quasi raddoppiato la superficie, l’antico Palazzo Raccuja, indicato anche con i nomi di Pietraperzia o Butera, era una delle più sontuose dimore patrizie della città, l’unica a non aver destinato parte dei suoi spazi all’apertura di botteghe al fine di trarne un utile dalla locazione. A pianta pressappoco quadrata, aveva quattro ingressi, uno per ogni lato e il collegamento tra i due originari corpi di fabbrica, ancora oggi visibile, era soltanto a livello del primo piano. Al piano terra del nuovo corpo di fabbrica venne realizzata una copertura con volte a crociera sostenute da colonne in marmo grigio di Billiemi, inusuale per la destinazione a scuderie.
Nel 1801, il Governo propose alla famiglia Branciforte di concedere l’intero edificio, per un canone annuo di circa 400 onze, al Senato Palermitano per farne la nuova sede del “Monte della Pietà per la Pignorazione” che ad inizio dell’Ottocento aveva bisogno di spazi più ampi per custodire la quantità dei pegni sempre crescente per effetto della difficile situazione economica.
La pratica fu definita in tempi brevissimi, una parte del Palazzo fu subito destinata alla sezione povera dei beni non preziosi, per il prestito su pegno di seteria e biancheria e successivamente di oggetti di rame e di bronzo. In omaggio alla Patrona della città, la filiale venne devotamente denominata “Monte di Santa Rosalia” anche se alla maggioranza dei palermitani rimase familiarmente nota sotto il nome di “panni vecchi”, con un evidente riferimento ai contenuti; per poterlo utilizzare interamente, furono avviati lavori di ristrutturazione che ne modificarono l’aspetto esterno.
Furono invece le conseguenze dell’incendio provocato dall’esplosione di una bomba durante la Rivoluzione nel gennaio del 1848 a portare la prima radicale modifica anche all’interno dell’antico edificio.
I lavori di restauro per la riattivazione del servizio di prestito su pegno non ripristinarono i solai crollati unificando in altezza gli ambienti della seconda e della terza elevazione dell’edificio.
Le ampie sale destinate alla conservazione degli oggetti vennero così dotate di ardite strutture di scaffalature lignee a tutta altezza con scale e palchetti che creano un insieme di fascinosi ambienti che oggi, in perfetto stato di conservazione, spogli di ogni sorta di materiale, sono universalmente riconosciuti un raro esempio ancora esistente di composizione architettonica lignea.
Nel 1929, l’antica istituzione, dopo quasi quattrocento anni di vita, viene assorbita dalla Cassa Centrale di Risparmio “Vittorio Emanuele” per le province siciliane. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la struttura subì numerosi nuovi danni provocati dai bombardamenti.
Il Palazzo che fu dei Branciforte continuò ad ospitare l’attività di credito su pegno di non preziosi fino a inizio degli anni ’80 quando divenne sede della Fondazione Chiazzese, dell’Archivio Storico e della Biblioteca della Cassa di Risparmio.
Alla fine degli anni Novanta, la Cassa di Risparmio venne acquisita dal Banco di Sicilia S.p.A. e Palazzo Branciforte divenne sede del Centro di Formazione per il personale bancario, funzione mantenuta anche dopo l’incorporamento del Banco di Sicilia nel Gruppo Capitalia.
Il 30 dicembre 2005, Palazzo Branciforte venne infine acquisito dalla Fondazione Banco di Sicilia.
Nel maggio 2012 il Palazzo, completamente restaurato nel suo splendore iniziale grazie al progetto di ripristino firmato dall’architetto Gae Aulenti, viene riaperto al pubblico come nuovo, importante polo culturale.
50 Recomendado por los habitantes de la zona
Palazzo Branciforte
2 Largo Gae AulentiAperto al pubblico nel maggio 2012, il Palazzo, che si sviluppa su 5.650 metri quadri di superficie, oltre ad ospitare gli uffici direzionali della Fondazione, offre spazio e fruibilità ad alcune prestigiose Collezioni della Fondazione stessa.
Al piano terra sono esposte la collezione archeologica della Cavallerizza e la collezione Mancini; al piano nobile sono custodite le collezioni filateliche, numismatiche, le sculture e le maioliche, insieme alla storica Biblioteca che conserva circa 50mila volumi della Fondazione. Da qui si può inoltre accedere ai suggestivi ambienti del Monte di Santa Rosalia, raro esempio ancora esistente di composizione architettonica lignea, destinata ora ad ospitare mostre d’arte temporanee.
A Palazzo Branciforte la cultura si coniuga anche con la buona tavola e con i sapori della tradizione mediterranea. In un’ala del piano terra è allestita la Città del Gusto, la celebre scuola di cucina del Gambero Rosso, rivolta sia ad un’utenza professionale che al più ampio pubblico degli appassionati. Attiguo alla scuola, in una straordinaria cornice architettonica è disponibile, anche fuori degli orari museali, il prestigioso Ristorante Branciforte.
L’Auditorium Branciforte attrezzato con le più moderne tecnologie può ospitare convegni ed eventi culturali, offrendo uno spazio esclusivo a chi desidera utilizzare il Palazzo per i propri incontri.
L’Emporio Branciforte propone al pubblico una selezionata offerta di prodotti editoriali e di oggettistica legati all’arte e alla enogastronomia.
Il coordinamento di tutte le attività, la gestione dei servizi museali e la promozione culturale di questo nuovo spazio sono affidati a Civita Sicilia.
La storia di Palazzo Branciforte ha un legame profondo con quella della città di Palermo fin da quando, nel XVII secolo, vi dimorava la famiglia di Nicolò Placido Branciforte Lanza conte di Raccuja.
Il nucleo originario del Palazzo è l’edificio costruito, con molta probabilità alla fine del Cinquecento, sull’area delimitata dalle odierne vie Bara, Lampedusa e Seminario Italo Albanese, il cui fronte principale prospettava sulla strada che allora collegava quelli che oggi sono i due ingressi principali.
Gli eredi del Conte di Raccuja, verso la metà del XVII secolo, ne avviarono l’ampliamento ottenendo dal Senato Palermitano di poter inglobare la strada antistante.
All’inizio del secolo successivo, completati i lavori che ne avevano quasi raddoppiato la superficie, l’antico Palazzo Raccuja, indicato anche con i nomi di Pietraperzia o Butera, era una delle più sontuose dimore patrizie della città, l’unica a non aver destinato parte dei suoi spazi all’apertura di botteghe al fine di trarne un utile dalla locazione. A pianta pressappoco quadrata, aveva quattro ingressi, uno per ogni lato e il collegamento tra i due originari corpi di fabbrica, ancora oggi visibile, era soltanto a livello del primo piano. Al piano terra del nuovo corpo di fabbrica venne realizzata una copertura con volte a crociera sostenute da colonne in marmo grigio di Billiemi, inusuale per la destinazione a scuderie.
Nel 1801, il Governo propose alla famiglia Branciforte di concedere l’intero edificio, per un canone annuo di circa 400 onze, al Senato Palermitano per farne la nuova sede del “Monte della Pietà per la Pignorazione” che ad inizio dell’Ottocento aveva bisogno di spazi più ampi per custodire la quantità dei pegni sempre crescente per effetto della difficile situazione economica.
La pratica fu definita in tempi brevissimi, una parte del Palazzo fu subito destinata alla sezione povera dei beni non preziosi, per il prestito su pegno di seteria e biancheria e successivamente di oggetti di rame e di bronzo. In omaggio alla Patrona della città, la filiale venne devotamente denominata “Monte di Santa Rosalia” anche se alla maggioranza dei palermitani rimase familiarmente nota sotto il nome di “panni vecchi”, con un evidente riferimento ai contenuti; per poterlo utilizzare interamente, furono avviati lavori di ristrutturazione che ne modificarono l’aspetto esterno.
Furono invece le conseguenze dell’incendio provocato dall’esplosione di una bomba durante la Rivoluzione nel gennaio del 1848 a portare la prima radicale modifica anche all’interno dell’antico edificio.
I lavori di restauro per la riattivazione del servizio di prestito su pegno non ripristinarono i solai crollati unificando in altezza gli ambienti della seconda e della terza elevazione dell’edificio.
Le ampie sale destinate alla conservazione degli oggetti vennero così dotate di ardite strutture di scaffalature lignee a tutta altezza con scale e palchetti che creano un insieme di fascinosi ambienti che oggi, in perfetto stato di conservazione, spogli di ogni sorta di materiale, sono universalmente riconosciuti un raro esempio ancora esistente di composizione architettonica lignea.
Nel 1929, l’antica istituzione, dopo quasi quattrocento anni di vita, viene assorbita dalla Cassa Centrale di Risparmio “Vittorio Emanuele” per le province siciliane. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la struttura subì numerosi nuovi danni provocati dai bombardamenti.
Il Palazzo che fu dei Branciforte continuò ad ospitare l’attività di credito su pegno di non preziosi fino a inizio degli anni ’80 quando divenne sede della Fondazione Chiazzese, dell’Archivio Storico e della Biblioteca della Cassa di Risparmio.
Alla fine degli anni Novanta, la Cassa di Risparmio venne acquisita dal Banco di Sicilia S.p.A. e Palazzo Branciforte divenne sede del Centro di Formazione per il personale bancario, funzione mantenuta anche dopo l’incorporamento del Banco di Sicilia nel Gruppo Capitalia.
Il 30 dicembre 2005, Palazzo Branciforte venne infine acquisito dalla Fondazione Banco di Sicilia.
Nel maggio 2012 il Palazzo, completamente restaurato nel suo splendore iniziale grazie al progetto di ripristino firmato dall’architetto Gae Aulenti, viene riaperto al pubblico come nuovo, importante polo culturale.
La Chiesa di Santa Croce si trova in via Roma, all’angolo con via Mariano Stabile, ed è il centro delle attività religiose della comunità anglofona di Palermo. Al suo interno si trova anche la cappella commemorativa delle famiglie Whitaker e Ingham. Infatti la chiesa fu costruita tra il 1871 e il 1875 grazie a Joseph Whitaker e Benjamin Ingham junior, che vollero fabbricare a loro spese una chiesa in cui celebrare il culto secondo i riti della Chiesa d’Inghilterra. Erano gli eredi di Benjamin Ingham senior, un gentiluomo inglese che si era stabilito in Sicilia e aveva costruito una piccola fortuna economica dal vino Marsala. I Whitaker-Ingham lasciarono segni di una cultura architettonica innovativa in tutta la Sicilia occidentale, ma soprattutto a Palermo, dove la loro influenza è ancora ben visibile in vari edifici della città.
Nella chiesa di Santa Croce, i Whitaker e gli Ingham erano determinati a dare un’impronta inglese all’edificio, importando porte, finestre, vetrate e pavimenti da aziende londinesi. Allo stesso tempo, non dimenticarono di rendere omaggio alla loro “nuova patria”, inserendo elementi architettonici arabo-normanni nelle decorazioni interne.
Il progetto della chiesa romanica a 3 navate fu affidato all’architetto londinese William Barber e i lavori iniziarono nel 1872 guidati dal colonnello Henry Yule. La chiesa fu inaugurata il 19 dicembre 1875 ed è oggi parte della Diocesi di Gibilterra in Europa (che copre circa 1/6 delle terre emerse).
Le varie vetrate, il grande rosone e l’alto campanile a guglia sono ispirati all’architettura gotica. Il marmo e le pietre utilizzate per costruire la chiesa provengono da Palermo, Carrara, Devonshire, Cornovaglia e Derbyshire.
Sulle vetrate, nel prospetto principale del muro ovest, sono rappresentati la Vergine Maria, Maria Maddalena e San Giovanni, testimoni ai piedi della Croce. Nel grande rosone che li sovrasta è raffigurata “l’Adorazione dell’Agnello da parte degli angeli”. Tutte le vetrate sono state progettate a Londra da Lavers, Barraud & Westlake e costruite dall’impresa Cox & Sons. Diverse vetrate furono danneggiate durante la seconda guerra mondiale, alcune furono rifatte, mentre altre furono sostituite da semplici vetri gialli (come le finestre laterali dell’abside).
Il punto focale della chiesa è la meravigliosa abside, con le affascinanti decorazioni disegnate dal famoso architetto britannico Francis Cranmer Penrose e realizzate dalla Ditta Salviati di Venezia. All’interno di una serie di nicchie trilobate si trovano dei mosaici che raffigurano i dodici apostoli (con San Paolo al posto di San Simone) e al centro il Cristo risorto venerato dagli angeli. Un fregio corre lungo le pareti dell’abside e l’iscrizione recita: “Him that cometh to me I will in no wise cast out” (Colui che viene a me non lo respingerò). In alto nell’abside ci sono cinque vetrate che rappresentano la prova, la crocifissione, la risurrezione, l’ascensione di Gesù e l’effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Anche il soffitto dell’abside è decorato con mosaici dorati che rappresentano i quattro evangelisti con Cristo al centro e sotto sono collocati i quattro dottori della Chiesa d’Occidente – Sant’Ambrogio, San Girolamo, Sant’Agostino e San Gregorio Magno. Interessanti sono le teste sui peducci che sorreggono i pilastri di marmo intorno all’abside, che rappresentano figure importanti per la Chiesa e la Riforma inglese: Sant’Agostino di Canterbury, Wycliffe, Cranmer, Edward VI, Lord Burghley e la regina Elisabetta I.
I quattro capitelli ai lati della pala dietro l’altare rappresentano, da sinistra a destra, l’Inghilterra con la rosa, l’Irlanda con il trifoglio, il Galles con l’iris, e la Scozia con il cardo.
Sulle varie pareti della chiesa si trovano numerose targhe commemorative in ottone in memoria delle famiglie Whitaker e Ingham, dei loro discendenti e dei loro impiegati.
La storia degli inglesi a Palermo
All’inizio del XIX secolo, quando la Sicilia fu per un breve periodo un protettorato britannico, la fiorente colonia di mercanti inglesi poté frequentare le funzioni religiose presso l’ambasciata britannica, mentre dal 1814 dovettero affidarsi ai cappellani delle navi da guerra in visita.
Solo dal 1840 le funzioni della chiesa anglicana di Palermo furono celebrate regolarmente. Si tenevano nel grande salone dipinto di Palazzo Lampedusa, residenza di John Goodwin, console britannico in Sicilia per oltre 32 anni.
Quando John Goodwin si trasferì a Palazzo Campofranco, anche le funzioni trovarono una nuova dimora, nella grande sala da ballo del palazzo.
Nel 1871 Joseph Whitaker e Benjamin Ingham annunciarono l’intenzione di erigere, a loro spese congiunte, una chiesa in cui le funzioni della Chiesa d’Inghilterra potevano essere svolti a beneficio spirituale dei loro connazionali protestanti, residenti o in visita a Palermo. Benjamin Ingham Jr. donò il terreno di fronte a Palazzo Ingham (ora Hotel delle Palme) per essere utilizzato come sede della nuova chiesa, e nel 1872 iniziarono i lavori di costruzione e furono poste le fondamenta. Tutte le spese dell’edificio furono pagate dalle famiglie Ingham e Whitaker.
Il 19 dicembre 1875 la chiesa fu aperta al culto.
Durante la seconda guerra mondiale, dopo l’invasione della Sicilia nel 1943, la Chiesa fu usata dalle forze statunitensi. Nel registro dei servizi ci sono note che dimostrano la presenza del generale Patton all’interno della struttura. E fu proprio il generale Patton a donare il memoriale presente nell’edificio, che commemora gli americani uccisi in Sicilia in quel periodo.
L’organo della chiesa, costruito da Walker’s di Londra, è stato suonato per la prima volta nell’ottobre 1903 e per celebrare il suo centenario è stato restaurato nel 2003.
Chiesa Anglicana Holy Cross Palermo
La Chiesa di Santa Croce si trova in via Roma, all’angolo con via Mariano Stabile, ed è il centro delle attività religiose della comunità anglofona di Palermo. Al suo interno si trova anche la cappella commemorativa delle famiglie Whitaker e Ingham. Infatti la chiesa fu costruita tra il 1871 e il 1875 grazie a Joseph Whitaker e Benjamin Ingham junior, che vollero fabbricare a loro spese una chiesa in cui celebrare il culto secondo i riti della Chiesa d’Inghilterra. Erano gli eredi di Benjamin Ingham senior, un gentiluomo inglese che si era stabilito in Sicilia e aveva costruito una piccola fortuna economica dal vino Marsala. I Whitaker-Ingham lasciarono segni di una cultura architettonica innovativa in tutta la Sicilia occidentale, ma soprattutto a Palermo, dove la loro influenza è ancora ben visibile in vari edifici della città.
Nella chiesa di Santa Croce, i Whitaker e gli Ingham erano determinati a dare un’impronta inglese all’edificio, importando porte, finestre, vetrate e pavimenti da aziende londinesi. Allo stesso tempo, non dimenticarono di rendere omaggio alla loro “nuova patria”, inserendo elementi architettonici arabo-normanni nelle decorazioni interne.
Il progetto della chiesa romanica a 3 navate fu affidato all’architetto londinese William Barber e i lavori iniziarono nel 1872 guidati dal colonnello Henry Yule. La chiesa fu inaugurata il 19 dicembre 1875 ed è oggi parte della Diocesi di Gibilterra in Europa (che copre circa 1/6 delle terre emerse).
Le varie vetrate, il grande rosone e l’alto campanile a guglia sono ispirati all’architettura gotica. Il marmo e le pietre utilizzate per costruire la chiesa provengono da Palermo, Carrara, Devonshire, Cornovaglia e Derbyshire.
Sulle vetrate, nel prospetto principale del muro ovest, sono rappresentati la Vergine Maria, Maria Maddalena e San Giovanni, testimoni ai piedi della Croce. Nel grande rosone che li sovrasta è raffigurata “l’Adorazione dell’Agnello da parte degli angeli”. Tutte le vetrate sono state progettate a Londra da Lavers, Barraud & Westlake e costruite dall’impresa Cox & Sons. Diverse vetrate furono danneggiate durante la seconda guerra mondiale, alcune furono rifatte, mentre altre furono sostituite da semplici vetri gialli (come le finestre laterali dell’abside).
Il punto focale della chiesa è la meravigliosa abside, con le affascinanti decorazioni disegnate dal famoso architetto britannico Francis Cranmer Penrose e realizzate dalla Ditta Salviati di Venezia. All’interno di una serie di nicchie trilobate si trovano dei mosaici che raffigurano i dodici apostoli (con San Paolo al posto di San Simone) e al centro il Cristo risorto venerato dagli angeli. Un fregio corre lungo le pareti dell’abside e l’iscrizione recita: “Him that cometh to me I will in no wise cast out” (Colui che viene a me non lo respingerò). In alto nell’abside ci sono cinque vetrate che rappresentano la prova, la crocifissione, la risurrezione, l’ascensione di Gesù e l’effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Anche il soffitto dell’abside è decorato con mosaici dorati che rappresentano i quattro evangelisti con Cristo al centro e sotto sono collocati i quattro dottori della Chiesa d’Occidente – Sant’Ambrogio, San Girolamo, Sant’Agostino e San Gregorio Magno. Interessanti sono le teste sui peducci che sorreggono i pilastri di marmo intorno all’abside, che rappresentano figure importanti per la Chiesa e la Riforma inglese: Sant’Agostino di Canterbury, Wycliffe, Cranmer, Edward VI, Lord Burghley e la regina Elisabetta I.
I quattro capitelli ai lati della pala dietro l’altare rappresentano, da sinistra a destra, l’Inghilterra con la rosa, l’Irlanda con il trifoglio, il Galles con l’iris, e la Scozia con il cardo.
Sulle varie pareti della chiesa si trovano numerose targhe commemorative in ottone in memoria delle famiglie Whitaker e Ingham, dei loro discendenti e dei loro impiegati.
La storia degli inglesi a Palermo
All’inizio del XIX secolo, quando la Sicilia fu per un breve periodo un protettorato britannico, la fiorente colonia di mercanti inglesi poté frequentare le funzioni religiose presso l’ambasciata britannica, mentre dal 1814 dovettero affidarsi ai cappellani delle navi da guerra in visita.
Solo dal 1840 le funzioni della chiesa anglicana di Palermo furono celebrate regolarmente. Si tenevano nel grande salone dipinto di Palazzo Lampedusa, residenza di John Goodwin, console britannico in Sicilia per oltre 32 anni.
Quando John Goodwin si trasferì a Palazzo Campofranco, anche le funzioni trovarono una nuova dimora, nella grande sala da ballo del palazzo.
Nel 1871 Joseph Whitaker e Benjamin Ingham annunciarono l’intenzione di erigere, a loro spese congiunte, una chiesa in cui le funzioni della Chiesa d’Inghilterra potevano essere svolti a beneficio spirituale dei loro connazionali protestanti, residenti o in visita a Palermo. Benjamin Ingham Jr. donò il terreno di fronte a Palazzo Ingham (ora Hotel delle Palme) per essere utilizzato come sede della nuova chiesa, e nel 1872 iniziarono i lavori di costruzione e furono poste le fondamenta. Tutte le spese dell’edificio furono pagate dalle famiglie Ingham e Whitaker.
Il 19 dicembre 1875 la chiesa fu aperta al culto.
Durante la seconda guerra mondiale, dopo l’invasione della Sicilia nel 1943, la Chiesa fu usata dalle forze statunitensi. Nel registro dei servizi ci sono note che dimostrano la presenza del generale Patton all’interno della struttura. E fu proprio il generale Patton a donare il memoriale presente nell’edificio, che commemora gli americani uccisi in Sicilia in quel periodo.
L’organo della chiesa, costruito da Walker’s di Londra, è stato suonato per la prima volta nell’ottobre 1903 e per celebrare il suo centenario è stato restaurato nel 2003.
Offerta gastronomica
Un posto dove si mangia davvero bene! I mangia e bevi palermitani sono tipici arrosticini palermitani con pancetta di maiale arrotolata sui cipollotti.
121 Recomendado por los habitantes de la zona
Osteria Mangia e Bevi
18 L.go dei Cavalieri di MaltaUn posto dove si mangia davvero bene! I mangia e bevi palermitani sono tipici arrosticini palermitani con pancetta di maiale arrotolata sui cipollotti.
Nel dopoguerra era una tipica osteria con cucina, posti dove l'oste cucinava il cibo che la gente comprava nel vicino mercato della Vucciria. Oggi è forse il posto migliore per la degustazione dei piatti tipici della cucina palermitana a prezzi accessibili ad ogni tipo di viaggiatore.
175 Recomendado por los habitantes de la zona
Ferro di Cavallo
20 Via VeneziaNel dopoguerra era una tipica osteria con cucina, posti dove l'oste cucinava il cibo che la gente comprava nel vicino mercato della Vucciria. Oggi è forse il posto migliore per la degustazione dei piatti tipici della cucina palermitana a prezzi accessibili ad ogni tipo di viaggiatore.
Cucina popolare e tipica palermitana ottima, con prezzi a portata di tutti.
66 Recomendado por los habitantes de la zona
Trattoria Al Vecchio Club Rosanero
18 Vicolo CaldomaiCucina popolare e tipica palermitana ottima, con prezzi a portata di tutti.
Mastunicola
La casa della pizza napoletana a Palermo.
Bontà sperimentata personalmente.
Nel 2004 la famiglia Sciarrino rileva Cagliostro, insegna presente a Palermo già dal 1981, in aggiunta alla cucina, reinventa la pizza proposta oggi, apprezzata a Palermo ed in tutta Italia, così da essere inserita dal 2020 nella prestigiosa guida 50 Top Pizza come “Pizzeria eccellente" e nella prestigiosa guida Gambero Rosso tra le migliori pizzerie d'Italia.
Marco Sciarrino, in aggiunta al forno dal fratello Ruggero, ha iniziato la sua grande ricerca, in particolar modo sulle farine, rigorosamente Petra Molino Quaglia, e sugli impasti. Ad occuparsi della sala è il terzo fratello Sciarrino: Danilo.
Tradizione familiare, gusto per l'innovazione e la sperimentazione, portano "CAGLIOSTRO" nell'olimpo della ristorazione palermitana e siciliana.
12 Recomendado por los habitantes de la zona
Cagliostro Ristorante
150 Via Vittorio EmanueleNel 2004 la famiglia Sciarrino rileva Cagliostro, insegna presente a Palermo già dal 1981, in aggiunta alla cucina, reinventa la pizza proposta oggi, apprezzata a Palermo ed in tutta Italia, così da essere inserita dal 2020 nella prestigiosa guida 50 Top Pizza come “Pizzeria eccellente" e nella prestigiosa guida Gambero Rosso tra le migliori pizzerie d'Italia.
Marco Sciarrino, in aggiunta al forno dal fratello Ruggero, ha iniziato la sua grande ricerca, in particolar modo sulle farine, rigorosamente Petra Molino Quaglia, e sugli impasti. Ad occuparsi della sala è il terzo fratello Sciarrino: Danilo.
Tradizione familiare, gusto per l'innovazione e la sperimentazione, portano "CAGLIOSTRO" nell'olimpo della ristorazione palermitana e siciliana.
Tutto quello che viene proposto nel menu è realizzato esclusivamente con prodotti siciliani. Panini veramente di qualità eccellente.
93 Recomendado por los habitantes de la zona
FUD
4 Piazza OlivellaTutto quello che viene proposto nel menu è realizzato esclusivamente con prodotti siciliani. Panini veramente di qualità eccellente.
Nel 1834 il Principe di Cattolica cede al cuoco di corte Salvatore Alaimo, la cappella del proprio palazzo di Piazza S. Francesco a Palermo: nasce così l’omonima Focacceria,
coniugando le tradizioni umili del cibo di strada, con l’amore per la migliore cucina popolare siciliana. Ingredienti tipici e ricette semplici segnano l’incontro tra culture diverse, nelle strade affollate di questa multietnica città. Gente comune, frequentatori illustri e personaggi storici: in molti sono passati dall’Antica Focacceria, mossi dal desiderio di deliziarsi con questi cibi tradizionali e saporiti, tramandati fin qui con passione, per tutti quelli che vorranno rinnovare con noi questo voto di gusto e tradizione. Benvenuti!
212 Recomendado por los habitantes de la zona
Antica Focacceria San Francesco
58 Via Alessandro PaternostroNel 1834 il Principe di Cattolica cede al cuoco di corte Salvatore Alaimo, la cappella del proprio palazzo di Piazza S. Francesco a Palermo: nasce così l’omonima Focacceria,
coniugando le tradizioni umili del cibo di strada, con l’amore per la migliore cucina popolare siciliana. Ingredienti tipici e ricette semplici segnano l’incontro tra culture diverse, nelle strade affollate di questa multietnica città. Gente comune, frequentatori illustri e personaggi storici: in molti sono passati dall’Antica Focacceria, mossi dal desiderio di deliziarsi con questi cibi tradizionali e saporiti, tramandati fin qui con passione, per tutti quelli che vorranno rinnovare con noi questo voto di gusto e tradizione. Benvenuti!
Per chi ama mangiare ad un livello più alto di qualità il ristorante dello chef Natale Giunta. Il profumo del mare, i colori della natura, la bellezza del porto di Palermo e l’atmosfera di una location senza eguali: questo è il Castello a Mare. Festeggia il tuo evento o trascorri una splendida serata nella nostra cornice.
6 Recomendado por los habitantes de la zona
Ristorante Castello a mare
Via Filippo PattiPer chi ama mangiare ad un livello più alto di qualità il ristorante dello chef Natale Giunta. Il profumo del mare, i colori della natura, la bellezza del porto di Palermo e l’atmosfera di una location senza eguali: questo è il Castello a Mare. Festeggia il tuo evento o trascorri una splendida serata nella nostra cornice.
Nelle belle e storiche sale di un'antica bottega, qui troverete un locale vivace e dinamico dove i piatti della tradizione si alternano con le stagioni. Tra i must: bucatini alle sarde e la proverbiale cassata. Il locale è gettonatissimo, meglio prenotare!
77 Recomendado por los habitantes de la zona
Buatta Cucina Popolana
176 Via Vittorio EmanueleNelle belle e storiche sale di un'antica bottega, qui troverete un locale vivace e dinamico dove i piatti della tradizione si alternano con le stagioni. Tra i must: bucatini alle sarde e la proverbiale cassata. Il locale è gettonatissimo, meglio prenotare!
Situato nel palazzo che ospitò la celebre scena del ballo nel Gattopardo di Luchino Visconti, il locale propone una cucina al passo coi tempi, i cui piatti moderni poggiano su veraci prodotti locali. Se la calorosa accoglienza e una gestione pluriennale costituiscono ulteriori incentivi alla sosta, c’è di più: nell'attiguo bistrot Occhio Vivo (esortazione siciliana per dire “Stai attento”!) si serve una cucina semplice e gustosa.
26 Recomendado por los habitantes de la zona
Osteria dei Vespri
6 Piazza Croce dei VespriSituato nel palazzo che ospitò la celebre scena del ballo nel Gattopardo di Luchino Visconti, il locale propone una cucina al passo coi tempi, i cui piatti moderni poggiano su veraci prodotti locali. Se la calorosa accoglienza e una gestione pluriennale costituiscono ulteriori incentivi alla sosta, c’è di più: nell'attiguo bistrot Occhio Vivo (esortazione siciliana per dire “Stai attento”!) si serve una cucina semplice e gustosa.
Nel cuore pulsante della città, tra la Vucciria e il porticciolo della Cala, questo locale dal design moderno e dai colori sgargianti valorizza ancor di più il fascino delle antiche mura che lo accolgono, nel Cinquecento bottega dello scultore Antonello Gagini. Lo chef Mauricio Zillo, dalla doppia nazionalità italiana e brasiliana, è approdato a Palermo dopo belle esperienze in giro per l'Europa. La sua cucina è molto personale, ricca di contrasti ma equilibrata. Non poteva essere diversamente visto il suo curriculum e le sue origini! Il servizio è attento, elegante ma con quel tocco d’informalità che mette l’ospite a suo agio. La carta dei vini svela un’ottima ricerca anche di piccoli produttori regionali.
48 Recomendado por los habitantes de la zona
Gagini
35 Via dei CassariNel cuore pulsante della città, tra la Vucciria e il porticciolo della Cala, questo locale dal design moderno e dai colori sgargianti valorizza ancor di più il fascino delle antiche mura che lo accolgono, nel Cinquecento bottega dello scultore Antonello Gagini. Lo chef Mauricio Zillo, dalla doppia nazionalità italiana e brasiliana, è approdato a Palermo dopo belle esperienze in giro per l'Europa. La sua cucina è molto personale, ricca di contrasti ma equilibrata. Non poteva essere diversamente visto il suo curriculum e le sue origini! Il servizio è attento, elegante ma con quel tocco d’informalità che mette l’ospite a suo agio. La carta dei vini svela un’ottima ricerca anche di piccoli produttori regionali.
Un’oasi di relax nel centro della località a cui si aggiunge un servizio cordiale e desideroso di rendere la vostra sosta un’esperienza memorabile. I piatti che arrivano in tavola sono ben preparati e ricchi di gusto, moderni quel tanto che basta senza - tuttavia - voltare le spalle alla tradizione. L’ispettore consiglia: "Tubettoni alla carrettiera di calamaro, tre pomodori e croccante di olive taggiasche"!
19 Recomendado por los habitantes de la zona
Ristorante Palazzo Branciforte
2 Via Bara All'OlivellaUn’oasi di relax nel centro della località a cui si aggiunge un servizio cordiale e desideroso di rendere la vostra sosta un’esperienza memorabile. I piatti che arrivano in tavola sono ben preparati e ricchi di gusto, moderni quel tanto che basta senza - tuttavia - voltare le spalle alla tradizione. L’ispettore consiglia: "Tubettoni alla carrettiera di calamaro, tre pomodori e croccante di olive taggiasche"!
Per noi la cucina di mare è un’attitudine. Significa rispetto. Nasce da un profondo senso di gratitudine, da quel tacito patto sancito con Madre Natura di cui i custodi sono i piccoli pescatori.
13 Recomendado por los habitantes de la zona
Aja Mola - Trattoria di Mare
39 Via dei CassariPer noi la cucina di mare è un’attitudine. Significa rispetto. Nasce da un profondo senso di gratitudine, da quel tacito patto sancito con Madre Natura di cui i custodi sono i piccoli pescatori.
Ottimo ristorante nel cuore della Palermo storica. Materie prime di qualità per un menù rispettoso della tradizione ma con piccole innovazioni davvero azzeccate. Tutto molto buono. Personale molto gentile. Una bella realtà da provare.
13 Recomendado por los habitantes de la zona
Sardina PastaBar
41/43 Via dei CassariOttimo ristorante nel cuore della Palermo storica. Materie prime di qualità per un menù rispettoso della tradizione ma con piccole innovazioni davvero azzeccate. Tutto molto buono. Personale molto gentile. Una bella realtà da provare.
We serve an original organic lunch and breakfast in Palermo. You can also shop many vegetarian, vegan, gluten free, sugar free options while you're at it.
Magasin bio avec plein d'options pour le pétit déj et le midi! Vous allez surement trouver votre bonheur entre un cafè ou chicorie, un verre de vin bio sicilien, un plat de riz et légumes gourmand... plein d'options de plats végétariens, en plein comfort, et en meme temps nous sommes un magasin pour vos achats locaux, bio, delicieux!
Serviamo originali pranzi e colazioni bio, con moltissime opzioni vegetariane, vegan, (ma non solo!) a prezzi convenienti! Inoltre siamo un negozio bio con un vasto assortimento di prodotti siciliani.
Ecologica
12 Piazza FonderiaWe serve an original organic lunch and breakfast in Palermo. You can also shop many vegetarian, vegan, gluten free, sugar free options while you're at it.
Magasin bio avec plein d'options pour le pétit déj et le midi! Vous allez surement trouver votre bonheur entre un cafè ou chicorie, un verre de vin bio sicilien, un plat de riz et légumes gourmand... plein d'options de plats végétariens, en plein comfort, et en meme temps nous sommes un magasin pour vos achats locaux, bio, delicieux!
Serviamo originali pranzi e colazioni bio, con moltissime opzioni vegetariane, vegan, (ma non solo!) a prezzi convenienti! Inoltre siamo un negozio bio con un vasto assortimento di prodotti siciliani.
Le Guide ai Quartieri
Dei colori e degli odori di questo mercato, così come ce li faceva immaginare il pittore Guttuso nel suo famoso quadro dal titolo Vucciria del 1974 (conservato a Palazzo Chiaramonte Steri), oggi non è rimasto quasi più nulla. L'antica "piazza di grascia", termine che in lingua italiana indica ogni sorta di genere alimentare e di vettovaglie, ha oggi lasciato il posto ad uno street food a cielo aperto che si popola soprattutto la sera.
Se avete voglia di mangiare cibi tipici della tradizione culinaria palermitana, accompagnando il tutto da buone bevute alla Taverna azzurra, non disdegnando di fare quattro salti perché nei fine settimana giovani deejay trasformano la piazza in una discoteca a cielo aperto, questo è il posto giusto.
95 Recomendado por los habitantes de la zona
Vucciria
Piazza CaraccioloDei colori e degli odori di questo mercato, così come ce li faceva immaginare il pittore Guttuso nel suo famoso quadro dal titolo Vucciria del 1974 (conservato a Palazzo Chiaramonte Steri), oggi non è rimasto quasi più nulla. L'antica "piazza di grascia", termine che in lingua italiana indica ogni sorta di genere alimentare e di vettovaglie, ha oggi lasciato il posto ad uno street food a cielo aperto che si popola soprattutto la sera.
Se avete voglia di mangiare cibi tipici della tradizione culinaria palermitana, accompagnando il tutto da buone bevute alla Taverna azzurra, non disdegnando di fare quattro salti perché nei fine settimana giovani deejay trasformano la piazza in una discoteca a cielo aperto, questo è il posto giusto.
Tra la Cala e la piazza San Domenico nel quartiere Castellammare c’è una strada che porta il nome delle maestranze che la abitarono, i materassai. La via dei Materassai si trova tra Il Piano San Giacomo e la piazza Garraffello nel cuore del mercato Vucciria. Certamente l'odierno degrado e abbandono non fanno nemmeno immaginare che questa strada fu teatro di una delle vicende più importanti nella storia di Palermo. Tra gli abitanti illustri che abitarono in questa via ricordiamo la famiglia Florio e la famiglia Ingham che vissero in via Materassai a cavallo del 1800.
I Florio in via dei Materassai al n. civico 51 aprirono la loro prima "putia" (negozio) di aromatari (drogheria). Inoltre, al numero 53 di via dei Materassai, sorse, nello stesso periodo, la prima residenza di quei bottegai arricchiti, destinati a passare agli onori della cronaca come “i regnanti senza corona”, autori di una fra le più importanti pagine di storia siciliana che è stata raccontata in due volumi da Stefania Auci, "I leoni di Sicilia" del 2019 e "L'inverno dei leoni" del 2021. Documentatissimo anche il volume di Salvatore Requirez dal titolo "Il leone di Palermo. La vita di Ignazio Florio" del 2022.
Via Materassai, 90133 Palermo PA, Italia
Tra la Cala e la piazza San Domenico nel quartiere Castellammare c’è una strada che porta il nome delle maestranze che la abitarono, i materassai. La via dei Materassai si trova tra Il Piano San Giacomo e la piazza Garraffello nel cuore del mercato Vucciria. Certamente l'odierno degrado e abbandono non fanno nemmeno immaginare che questa strada fu teatro di una delle vicende più importanti nella storia di Palermo. Tra gli abitanti illustri che abitarono in questa via ricordiamo la famiglia Florio e la famiglia Ingham che vissero in via Materassai a cavallo del 1800.
I Florio in via dei Materassai al n. civico 51 aprirono la loro prima "putia" (negozio) di aromatari (drogheria). Inoltre, al numero 53 di via dei Materassai, sorse, nello stesso periodo, la prima residenza di quei bottegai arricchiti, destinati a passare agli onori della cronaca come “i regnanti senza corona”, autori di una fra le più importanti pagine di storia siciliana che è stata raccontata in due volumi da Stefania Auci, "I leoni di Sicilia" del 2019 e "L'inverno dei leoni" del 2021. Documentatissimo anche il volume di Salvatore Requirez dal titolo "Il leone di Palermo. La vita di Ignazio Florio" del 2022.